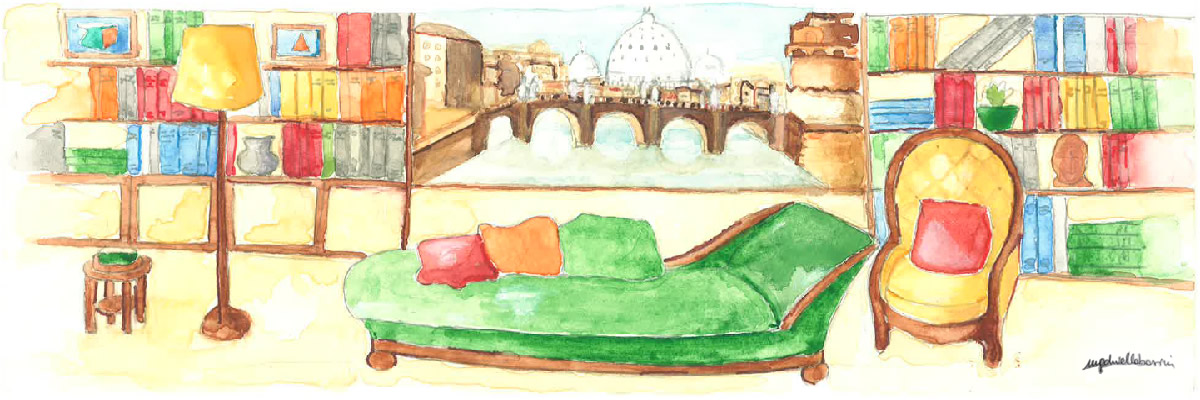Focus e Dintorni
Sándor Ferenczi: Il bambino non voluto e il suo istinto di morte (26 ottobre 2023). Report di Carlotta Facchini
- Dettagli
- Categoria: Focus e Dintorni

Alessandra Balloni introduce la serata che si apre con la presentazione del libro Prendersi in gioco di Marta Badoni. L’autrice attraverso il suo sguardo curioso e accorto conduce il lettore nella vita dell’istituzione psicoanalitica, capace di facilitare il lavoro e il confronto nel gruppo così come l’espressione dell’originalità di ciascuno. Marta Badoni presenta un volume in cui raccoglie scritti inediti, lavori già presentati e rivisti e pensieri recenti, intrecciando riferimenti a grandi autori come Ferenczi e Freud e sue proprie vicende familiari. Introduce così l’origine delle sue elaborazioni e il suo modo di intendere lo stare con il paziente, mettendosi in gioco e permettendo al lettore di immergersi in uno scenario di vita.
David Ventura presenta l’ospite della serata, Adrienne Harris, psicoanalista americana che ha ricevuto diversi premi per la sua opera scientifica. Harris ha redatto numerosissimi articoli e testi e ha fondato il Sándor Ferenczi Center che si occupa della diffusione, approfondimento e applicazione del pensiero di Ferenczi. Molteplici sono le cariche ricoperte da Harris nelle riviste psicoanalitiche più importanti, tra cui è editor della collana di psicoanalisi relazionale “Relational Perspectives” in cui ha pubblicato circa una novantina di libri. Si è sempre occupata del trauma, delle differenze di genere, così come delle tensioni e i movimenti che attraversano la società contemporanea.
Adrienne Harris, grande studiosa del pensiero di Ferenczi, propone un lavoro su un saggio dell’autore del 1929 e intende rilevare le connessioni tra quest’opera e il lavoro sulle nevrosi di guerra e il suo interesse per la pulsione di morte. Mentre a Vienna e a Berlino dominavano le teorie dell’inconscio e l’attenzione alla struttura psichica dell’individuo, fin dal 1900 e poi nel 1913 la scuola di Budapest manifestò un forte interesse per il processo clinico e il trattamento, focalizzandosi sul transfert e sul processo di formazione di una relazione nel trattamento, da cui è nata l’attenzione sullo sviluppo infantile e sul processo clinico. Secondo il pensiero di Meszaros, è grazie a Ferenczi e al suo focus sulla maternità, che il mondo psicoanalitico ha volto l’attenzione allo studio dello sviluppo. Ferenczi, rispetto a Freud, si muove verso la cura e la strutturazione di un progetto di aiuto.
Meszaros nota che il modello originale dell’analisi passa da una serie di analisi dei sogni a una visione dell’analisi come processo di sviluppo nella situazione analitica. Nel suo saggio del 1917 sulle nevrosi di guerra, Ferenczi ha un approccio molto diverso da quello di Freud riguardo agli effetti traumatici della guerra e offre una visione chiara di cosa sia lo shellshock, la psicosi traumatica, prestando attenzione allo stato corporeo degli uomini traumatizzati e notando come l’esperienza di essere ‘incorporati’ nel mondo fosse stata alterata dal modo moderno di fare la guerra. In questo saggio Ferenczi conduce il lettore fra i reparti di un ospedale militare e mostra i corpi di uomini tremanti, bloccati, in preda ad angosce inimmaginabili e allo stesso tempo mostra le sue riflessioni sullo shellshock, nella realtà delle nevrosi di guerra, nei crolli psichici e nella loro frammentazione. Ferenczi conclude che il trauma di guerra è psicogeno e ne illustra i sintomi corporei: tremori, brividi, contrazioni, difficoltà a camminare e paralisi, laddove non vi sono lesioni organiche. Nota che molte delle persone mono-sintomatiche presentano come sintomo la posizione fisica o il movimento che avevano assunto nel momento immediatamente precedente la catastrofe, nel tentativo di fermare il tempo all’attimo prima della tragedia. Proprio nel momento in cui si verifica la catastrofe, una parte di loro si blocca. È come se il momento del trauma fosse sempre nella memoria del sopravvissuto sul punto di accadere, o stia accadendo in quel preciso momento. È un sintomo carico di après-coup, di azione differita, che racconta e nasconde la storia di ciò che ha creato il crollo psichico ed è il corpo che tiene il vissuto traumatico intrappolato e perduto. Ferenczi ‘legge’ i corpi di questi soldati e osserva una regressione nel pattern dei loro sintomi, come se il tempo e lo sviluppo si fossero invertiti. È quindi il corpo ad avere il primato come sito del trauma, che è però sia reale che psicogeno e dunque prevede l’interazione di due livelli di soggettività, somatico e psichico.
Ferenczi, nel saggio Il bambino indesiderato e il suo istinto di morte del 1929, collega la malattia al dolore infantile precoce, laddove l’impatto dell’abbandono viene messo in relazione alle malattie e alle condizioni legate ai disturbi autoimmuni, ponendo così le basi per il lavoro delle successive scuole psicoanalitiche incentrate sulla psicosomatica. Qui Ferenczi fa riferimento al suo lavoro durante la Prima Guerra mondiale presso l’ospedale psichiatrico e collega quei sintomi all’istinto di morte e queste condizioni patologiche, i sintomi somatici e le malattie, a un neglect precoce. Descrive un bambino ospite indesiderato della famiglia che in queste circostanze può morire facilmente e volontariamente e che, sia da bambino che da adulto, ha combattuto contro le sue tendenze suicidarie, rifiutandosi di attaccarsi o creare legami. Una sorprendente teorizzazione, quasi 30 anni prima di Bowlby.
Ferenczi propone un’elasticità della tecnica per lavorare con questi casi, che mira alla sollecitazione vitale di fronte ad un vuoto come esperienza di assenza, non riempita e apparentemente non riempibile, come la psychose blanche di Green. Harris sottolinea come Ferenczi abbia anticipato gli sviluppi successivi relativi all’attaccamento e l’attenzione all’impatto degli eventi traumatici precoci sulla vita mentale così come l’interazione tra vissuti corporei e inconsci.
Dalla sala emergono numerose le domande che si rincorrono in un ricco scambio.
Diversi interventi convergono rispetto alle continuità e alle discontinuità tra il trauma di guerra e il trauma precoce di un bambino male accolto. Il trauma di guerra è, come ogni trauma, l’intervenire di qualcosa di non voluto, indesiderato. Ad esempio, si chiede Harris, è desiderato, da parte di un genitore, che il bambino sviluppi una mente adulta e un corpo adulto? O che sviluppi un’identità sessuale che non corrisponde alle aspettative o ai desideri genitoriali?
Nel trauma di un bambino non voluto, così come nel trauma di guerra, viene vissuta una situazione di estrema vulnerabilità con conseguenti difficoltà relative all’integrazione del trauma. Mentre per alcuni sembra dunque che si possa individuare un parallelismo tra le due situazioni traumatiche, secondo altri invece non si possono equiparare poiché l’uno è un bambino che non ha ancora sviluppato l’Io e si sta formando, mentre l’altro è un adulto che può in qualche modo avere più possibilità di integrazione dell’esperienza traumatica.
Altri interventi si concentrano sull’odio e l’istinto di morte collegati al trauma. Diverse sono le esperienze con pazienti che vivono in aree dissociate della mente collegate al rifiuto. L’odio in alcuni casi diventa una dimensione difensiva rispetto a situazioni in cui le identificazioni con un nulla risultano appartenere a identificazioni con un nulla cattivo, altre invece prevedono una posizione della mente in cui c’è una tendenza ad essere asserviti con l’istinto di morte. Ci si chiede se le due situazioni siano differenziabili. Di comune hanno sicuramente la condivisione di situazioni traumatiche in cui vi è un vuoto interno che sembra più assimilabile all’istinto di morte, un congelamento che è come una morte interna, un black hole attrattivo per l’apparato mentale, il cui nucleo la coscienza fatica a sciogliere.
La frase di Beckett “allo stesso tempo la mia vita è finita eppure continua, ma esiste un tempo grammaticale per questo?” stimola riflessioni sul tempo e sullo stop time del trauma di guerra, di un tempo che si congela, così come si congela il corpo. Alcuni vissuti possono sconvolgere così profondamente da creare una rottura nella continuità dell’essere, eventi così sorprendenti e orribili che provocano discontinuità rispetto alla continuità temporale.
Harris sostiene siano tutte domande ancora aperte, a cui è difficile rispondere poiché sono molteplici i fattori che giocano intorno al trauma, come ad esempio qual è il ruolo della vergogna, del senso di colpa, dell’odio o dell’istinto di morte? Come organizzare e dare forma ai nostri vissuti di trauma per poter assimilare certi fenomeni? Serve un linguaggio più complesso per pensare al trauma e alle sue varie formazioni.
Ci si interroga infine sulle tecniche per il dis-incistamento di memorie traumatiche e quali orientamenti siano più adatti. Harris riporta che negli Stati Uniti si sta realizzando un lavoro sistematico sul trauma che si rivolge anche alla psichedelia in ambito medico. L’uso degli allucinogeni ha una tradizione che risale agli anni ‘60 e si sta riflettendo se sia possibile e come possano essere utilizzati per alterare certe disfunzioni e per lavorare sul trauma in un setting psicoanalitico.
Sono diversi anche i riferimenti alle attuali guerre in atto e le domande che sorgono rispetto al ruolo che noi, testimoni di tali atrocità, noi che siamo più al sicuro, potremmo assumere. Quale attivismo politico adottare pensando al trauma e alla vulnerabilità? Quale il ruolo da assumere a livello culturale, individuale, collettivo?
Vedi anche
Sándor Ferenczi: Il bambino non voluto e il suo istinto di morte (26 ottobre 2023)
Psicoanalisi e organizzazioni istituzionali (CdPR-CPdR, 16 dicembre 2023). Report di Veronica Nicoletti
- Dettagli
- Categoria: Focus e Dintorni

Il giorno 16 dicembre 2023 si è svolto on line il seminario del Gruppo intercentri di Roma (Centro di Psicoanalisi Romano e Centro Psicoanalitico di Roma) “Psicoanalisi e Istituzioni”, che ha visto il coinvolgimento dei gruppi di Psicoanalisi e Istituzioni e dei Soci nel Ruolo Pubblico per un reciproco confronto su un tema di lavoro comune e la possibilità di creare collaborazioni tra gruppi a diversa estensione territoriale, il primo che interessa la realtà romana e il secondo a carattere nazionale e di più recente costituzione.
Paola Ferri presenta l’intervento polifonico del gruppo Nazionale dei Soci nel Ruolo Pubblico pensato per la giornata odierna dal tema “Esperienze e riflessioni tra Istituzioni, Formazione e Psicoanalisi” e precisa che si articolerà in tre brevi interventi collettanei tesi a descrivere le esperienze formative dal vertice Universitario, dei Servizi Sanitari Pubblici e del Tirocinio.
Prende la parola Antonella Granieri del gruppo Nazionale dei Soci nel Ruolo Pubblico con delega del Centro Torinese di Psicoanalisi, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Torino. Nel suo intervento, curato insieme a Loredana Betti e Riccardo Galliani, viene descritta la circolarità virtuosa che si è creata, per il tramite dei tirocini formativi, tra Università e Servizi, con il fine di trasmettere la cultura e il sapere psicoanalitico al di fuori degli studi privati. I colleghi riportano, in particolare, due esperienze formative significative all’interno della Scuola di Specializzazione: una prima esperienza nel 2001 con Garcia Badaracco con il quale è nato un confronto continuativo; una seconda esperienza a febbraio 2023 a partire dal Manifesto della Salute Mentale della SPI, nella quale si è condivisa una visione della Salute Mentale non solo nelle configurazioni psichiatriche, ma anche in tutte le altre forme di disagio diffuse nella società. Infine, viene condivisa l’esperienza di Riccardo Galliani dell’Università di Caserta e di Loredana Betti, i quali hanno organizzato due cicli di incontri seminariali nel 2022 e nel 2023 presso Università Luigi Vanvitelli, incentrati sul lavoro della cura nella Salute Mentale Pubblica orientata al modello Psicoanalitico.
A seguire interviene Rossana Calvano per parlare delle esperienze formative dal vertice dei Servizi Sanitari Pubblici, in particolare riportando l’esperienza del gruppo al lavoro con il metodo delle libere associazioni. All’inizio dell’anno il responsabile del Centro di Consultazione e Terapie Psicoanalitiche (CCTP) del Centro Napoletano di Psicoanalisi ha promosso un rapporto di collaborazione con l’Università e i Servizi di Salute Mentale, attraverso la costituzione di gruppi di intervisione condotti secondo il metodo delle libere associazioni, ispirato al modello delle “Waeving Thoughts”, ma riadattato all’esperienza. Si sono quindi attivati gruppi di intervisione clinica a cadenza mensile presso due Servizi di Salute Mentale di cui è responsabile la stessa Rossana Calvano, che hanno visto il coinvolgimento delle equipe multiprofessionali dei servizi su materiale clinico presentato a turno da vari operatori. Un’analoga iniziativa è nata poco dopo con giovani colleghi iscritti al II anno della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Napoli. Nel complesso tali esperienze, condotte in due contesti differenti ma con il medesimo metodo, hanno portato vantaggi significativi nel funzionamento del gruppo di lavoro e nell’assetto mentale dei singoli operatori, oltre a svolgere una funzione ponte, di attivazione di circolarità tra una istituzione sanitaria pubblica, con il prevalente mandato della cura, e una istituzione universitaria, con il prevalente mandato della didattica. Calvano infine riporta esperienze analoghe condotte dalle colleghe Marangoni e Saccani presso il servizio Ri.Se.A. (Ricerca Servizio Adolescenza) e il CSM di Ravenna. Prendendo spunto da queste esperienze Paola Ferri propone di attivare, a scopo formativo per i candidati e di aggiornamento per i soci della SPI, il confronto tra esperienze simili vissute in contesti pubblici e libero professionali, oltre che riattivare l’Infant Observation per l’educazione affettiva tra i giovani e per la prevenzione della violenza sulle donne, tema di forte attualità.
L’esperienza formativa dal vertice del Tirocinio viene presentata da Maria Moscara che racconta l’esperienza pensata insieme ai colleghi Giovanna Cocchiarella, Maria Teresa Colella, Marisa Foglia e Francesca Mancia dei tirocini formativi nei luoghi di cura dei Servizi Pubblici dedicati alla Salute Mentale e alla Prevenzione Primaria (Centri di Salute Mentale, Centri Diurni, SPDC, Consultori) aperti a giovani laureati in Medicina, in Psicologia, in Scienze Infermieristiche, allievi delle Scuole di Specializzazione in Medicina Generale, in Psicoterapia compresi i candidati SPI. L’esperienza formativa si configura come “esperienza sul campo” che mira a trasmettere il metodo psicoanalitico tramite un lavoro gomito a gomito con il tirocinante, che possa veicolare l’attitudine analitica di sperimentarsi a cogliere ciò che non è immediatamente decodificatile nelle comunicazioni dei pazienti e nei fenomeni clinici, di avere un pensiero non giudicante o manicheo, di creare spazi di pensabilità, di contemplare le differenze e tentare di integrarle. Viene, inoltre, ricordata l’esperienza dei tirocini nell’Ambulatorio della Gravidanza, nel Consultorio Teenagers e negli incontri protetti per l’affido a rischio giuridico.
Chiude l’intervento sui tirocini una riflessione riguardo ai canditati tirocinanti dell’INT (Istituto Nazionale del Training) che, per obbligo formativo, si trovano a dover fare il tirocinio nei servizi pubblici, ma che spesso vivono l’esperienza come un corpo estraneo rispetto ai programmi seminariali, in quanto per alcuni di loro l’esperienza del tirocinio formativo nelle istituzioni sanitarie rappresenta la prima esperienza viva di pratica clinica, che spesso manca di quell’accoglienza e formazione sul campo in sintonia con i programmi seminariali del Training, auspicabile invece in un’ottica circolare tra psicoanalisti-tutor e candidato-istituzione
Alla fine della presentazione dei lavori dei Soci nel Ruolo Pubblico, Giuseppe Riefolo evidenzia l’intento comune tra i colleghi presenti di trasmettere una “sensibilità analitica” agli operatori che lavorano nei servizi, proponendola sia come base formativa, sia come modalità di lavoro congiunto anche tra esperti.
Senza interruzione seguono quindi gli interventi del gruppo di Psicoanalisi e Istituzione.
Marco Grignani, Direttore del DSM della USL Umbria 1, presenta l’esperienza di una giornata formativa del Corso di Formazione Regionale in Psicoanalisi Multifamiliare nella Salute Mentale di Perugia organizzata a Marzo 2023. I conduttori del Gruppo Multifamiliare (GMF) - attivato in una comunità a orientamento psicodinamico secondo il modello di Badaracco - Marco Grignani e Ilaria Persiani- hanno proposto ai membri del GMF di partecipare a una giornata formativa per promuovere una riflessione in gruppo sull’esperienza del GMF della comunità, proposta accettata di buon grado dai colleghi di Roma Andrea Narracci e Fausta Calvosa, i quali si sono posti come co-artefici di questo modello di formazione fondato sull’esperienza diretta. L’esperienza ha avuto luogo nell’aula formativa dell’Ospedale di Perugia, con il setting scelto a forma di acquario, con il GMF della comunità al centro della sala (composto dagli abitanti della comunità, operatori e familiari) e i partecipanti alla giornata formativa in un cerchio più esterno. L’evento è durato circa un’ora e mezza e ha assunto le caratteristiche proprie di un gruppo multifamiliare, in quanto le comunicazioni di un paziente del GMF della comunità hanno consentito, con la facilitazione dei conduttori del gruppo, l’amplificazione dei vissuti ad altri partecipanti ed il raggiungimento di una comprensione profonda dell’esperienza, che ha avviato un tentativo di rielaborazione di quanto sperimentato dai pazienti e dai familiari nella propria esperienza di vita. La descrizione dell’esperienza vissuta ha veicolato, anche nella giornata odierna, i livelli emotivi esperiti che si sono riflessi nell’ascolto partecipato di tutti. Riefolo alla fine ha evidenziato l’utilità di attivare delle modalità di lavoro che privilegino l’intimità quali il dispositivo gruppale, che andrebbe promosso nel lavoro istituzionale.
Prendono la parola successivamente Flaminia Cordeschi e Anna Bovet che, parlando a braccio, riportano la loro esperienza dei seminari clinici avviati all’interno del servizio per Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dove lavorano. La proposta clinica parte dalla considerazione che il disturbo alimentare si presenta di per sé come connotato da una profonda scissione corpo-mente, con l’attivazione di difese dissociative importanti che possono essere riprodotte nell’equipe di lavoro. La possibilità di attivare momenti di confronto clinico con il dispositivo gruppale tra tutti gli operatori e le diverse figure professionali coinvolte nella gestione del singolo caso consente allora di utilizzare la mente del gruppo per cogliere aspetti muti, nuovi aggregati non pensabili dalla mente individuale, che possano consentire il recupero di quel contatto mente-corpo spesso dissociato nei pazienti.
La dimensione del seminario clinico di gruppo consente di creare una “rete mentale” tra servizi, che sembra rispondere meglio a esigenze formative e di confronto clinico, così fondamentale nel lavoro con quelle patologie gravi che coinvolgono la mente e il corpo in maniera massiccia e dissociata. Vengono quindi presentati sette casi clinici di età diverse e problematiche differenti tra loro, dai quali emerge la potenzialità dello strumento gruppale per trasformare vissuti emotivi significativi quali sentimenti di impotenza e angoscia di morte in prospettive evolutive.
Anna Bovet rintraccia, nell’esperienza del seminario clinico di gruppo, alcuni aspetti trasversali ai singoli casi che possono essere pensati come “fattori terapeutici di base”. Il clima di forte confidenza e spontaneità che si attiva nei gruppi permette l’esposizione libera e fiduciosa del proprio pensiero a tutti i partecipanti, consentendo di superare impasse nella clinica grazie alla possibilità di condividere criticità in un clima sentito come accogliente e inclusivo. Rileva che il sintomo alimentare è spesso vissuto come funzionale in modo inconscio a manovre relazionali, volte a richiamare l’attenzione dell’altro, oltre che come baluardo difensivo a livello individuale per il recupero di una dimensione di sicurezza di sé e definizione dei propri confini esterni e interni.
Inoltre, nella dimensione gruppale, si recupera un funzionamento mentale associativo e simbolico utile a superare la dimensione asfittica non simbolizzante in cui tende a cadere la coppia terapeuta-paziente con un DCA. Allo stesso modo, la circolarità del pensiero di gruppo facilita l’uscita da una dimensione dell’esperienza clinica vissuta in termini prestazionali di recuperi e di fallimenti, consentendo all’equipe di riacquistare una dimensione psichica in grado di contemplare la complessità e superare livelli di frustrazione e impotenza. Infine, nella dimensione gruppale, si può recuperare anche la componente trans-generazionale del disturbo che opera la trasmissione inconscia di pattern relazionali familiari.
Riefolo commenta l’esperienza delle colleghe evidenziando il ruolo che la psicoanalisi può apportare nel riattivare e tenere viva la propensione alla mentalizzazione e al pensiero simbolico negli operatori impegnati nella cura delle patologie gravi nei servizi.
Concludono gli interventi della mattinata Sabrina Gubbini e Giorgio Campoli che presentano l’esperienza di seminari clinici di gruppo e di intervisione che conducono da anni presso il CSM della UOC Salute Mentale D9 della ASLRM2, un servizio descritto dalla collega Barbara Fedeli che vi lavora. I colleghi sottolineano l’efficacia del pensiero gruppale, attivato tramite il coinvolgimento emotivo di tutti i partecipanti all’esperienza, che consente di rintracciare dei movimenti evolutivi nel funzionamento del paziente e nelle interazioni familiari.
Al termine della presentazione dei lavori si avvia prontamente la discussione in un clima affettivo e partecipato, con numerosi interventi sia dei relatori che degli altri presenti e che si configura come un momento utile a rintracciare punti di connessione e convergenze di lavoro tra i colleghi coinvolti.
Viene ribadito l’intento comune di un impegno congiunto nel trasmettere la “sensibilità analitica” all’interno dei servizi di Salute Mentale, anche attraverso la Formazione e la peculiarità dell’uso del gruppo come strumento utile a intercettare la complessità clinica dei pazienti, a sostenere la “gravosità” del lavoro istituzionale e manutenere un assetto mentale associativo degli operatori nei servizi e nelle istituzioni psicoanalitiche.
Vedi anche
Psicoanalisi e organizzazioni istituzionali (16 dicembre 2023)
Altri articoli...
- L'Angolo Custode - Appunti sul tempo, di Guido Berdini
- Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, 25 novembre 2023. "C'è ancora domani (Ma non per tutte)". Note con cronaca di Mariaclotilde Colucci
- Transgender Day of Remembrance (TDoR), 20 novembre 2023. A cura di Laura Porzio Giusto
- Immaginare il futuro: il pensiero oltre le angosce catastrofiche e il diniego (CdPR- CPdR, 4 novembre 2023). Report di Mariaclotilde Colucci
- Sigourney Award 2023 a Vittorio Lingiardi
- Benedetto Genovesi, "Accedere alla memoria implicita"
- "Il caftano blu". Osare il cambiamento. Note di Adriana D'Arezzo
- I nostri libri (7 ottobre 2023). Report di Rodolfo Antonini
- Io Capitano, di Matteo Garrone. Note di Mariaclotilde Colucci
- Dissociazione, rimozione e ritorno. La parabola di trent’anni del concetto di difesa in Freud e nella psicoanalisi contemporanea (14 settembre, 2023). Report di Flaminia Vacchini
Powered by Multicategories for Joomla!2.5