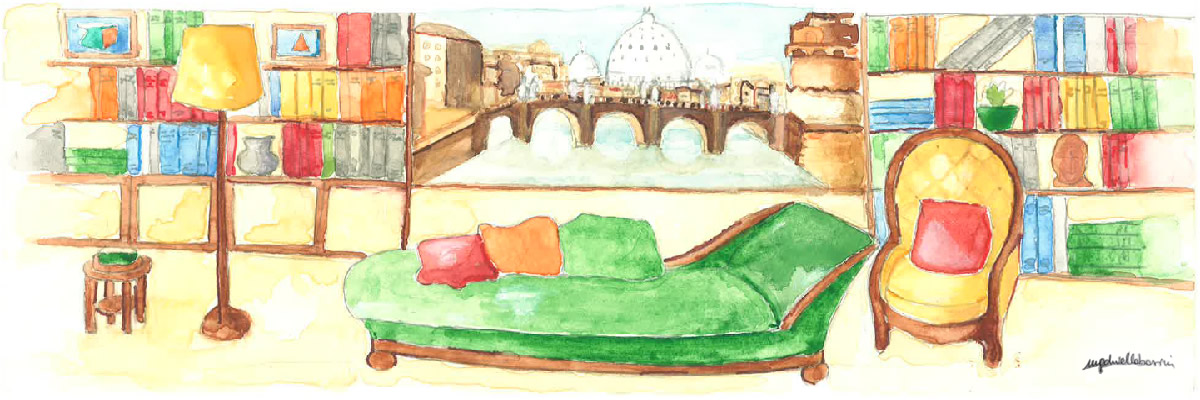Focus e Dintorni
"Il caftano blu". Osare il cambiamento. Note di Adriana D'Arezzo
- Dettagli
- Categoria: Focus e Dintorni

Regia di Maryam Touzani, con Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Messioui
Titolo originale: The Blue Caftan
Genere: drammatico
Marocco, 2022
Durata: 122 minuti
Il tema del film non è particolarmente originale come non lo è la metafora sartoriale, ma il contesto ed il linguaggio sono interessanti. È la storia di un cambiamento, della lenta emersione della soggettività, della rinuncia graduale alla vita clandestina nell’anonimato del conformismo. I personaggi sono descritti con la delicatezza dell’indagine psicologica frutto di una raffinata sensibilità. Come accade spesso nella richiesta di trattamento psicoanalitico, ci sono circostanze della vita, una malattia, una separazione, un lutto, in cui diventa possibile avviare processi trasformativi prima impensabili.
Helim e Mina sono una coppia affiatata che gestisce una piccola sartoria in cui si confezionano caftani tradizionali nel cuore della medina di Salé, in Marocco. Nonostante l’evidente affiatamento della coppia si respira un’atmosfera pesante, una sofferenza sotterranea attraversa la vita dei personaggi, il mondo esterno sottilmente ostile. Helim è un sarto raffinato ma gli affari non vanno bene, la clientela sembra incapace di apprezzare materiali e lavoro accurato, pretende una velocità incompatibile con il tipo di lavoro che loro propongono.
Mina è seriamente ammalata, Helim le sta accanto teneramente. Un giovane apprendista, Youssef, si inserisce per aiutarli, ora al negozio sono spesso in tre, lui cuce e insegna antiche tecniche sartoriali, lei seleziona i materiali e parla con la clientela. L’amore e la cura pervade ogni ambito. Ogni gesto è prezioso. Nella quotidiana vicinanza tra Halim e Youssef affiorano antichi desideri rimasti sopiti e incapsulati, aree probabilmente vissute come impresentabili. Diviene palese una omosessualità che era stata a lungo negata e relegata in brevi clandestini incontri nel segreto dell’hammam, forse temuta per gli effetti deflagranti.
Il film si svolge quasi interamente in spazi interni, la casa, il negozio, l’hammam, la luce è fioca. Un’atmosfera faticosa anche per chi guarda, i tempi sembrano troppo lunghi. Eppure la sapienza delle inquadrature, i primi piani sui dettagli catturano pian piano lo spettatore rendendolo attento e curioso.
Per Helim, cresciuto senza il sostegno dello sguardo materno, morta alla sua nascita, e nel risentimento di quello paterno, il percorso di vita è stato accidentato, ma lui apparentemente non recrimina, cuce, ritirato in un mondo che lo protegge e lo imprigiona. La paura governa il tempo, rende difficile uscire alla luce del sole. Mina nonostante la malattia che avanza è una donna battagliera e profondamente onesta.
Con gli occhi di uno psicoanalista possiamo pensare che per Helim il trauma dell’assenza di sguardo, il tradimento dell’originaria aspettativa di reciprocità, in un’epoca dello sviluppo in cui non era per lui ancora possibile dare forma di pensiero a questa mancanza, abbia generato una ferita che mina la legittimazione alla vita soggettiva. Talvolta, come nel caso di Helim, incontri successivi possono in qualche modo prendersi cura del dolore, possiamo immaginare che ci sia una profonda condivisione che lo rende possibile.
Costruire la propria libertà richiede tempo, come confezionare caftani, può essere fatto utilizzando tecniche differenti. La ricerca dei materiali, la qualità e i colori delle sete e del filo, la sua torsione ottimale ne determina la durata nel tempo. La bellezza cura, sembra pensare Maryam Touzani regista e sceneggiatrice marocchina che dirige con maestria attori bravissimi. Anche l’amore e la dolcezza coniugati con la forza e la determinazione curano. Diviene possibile tessere connessioni tra piani differenti, ci si aspetterebbe la gelosia di Mina quando Youssef diventa sempre più presente in casa ma qualcosa di più prezioso deve essere preservato. Anche la paura in un contesto come quello del Marocco, la cui legislazione punisce l’omosessualità con il carcere fino a tre anni, può essere affrontata. La prossimità della fine di Mina impone un cambio di passo nelle loro vite e la loro umanità si espande verso il futuro. Come in un contesto psicoanalitico a poco a poco i personaggi acquistano spessore, diventa possibile avvicinare il proprio mondo interno, rintracciare il senso delle cose.
Con il sostegno dello sguardo solidale dell’altro diventa possibile liberare potenzialità inesplorate.
Nella bella danza che i tre improvvisano trascinati dalla musica, davanti ad una finestra aperta che pare simbolizzare nuove possibilità di scambi col mondo esterno, si può finalmente godere di un piacere che coniuga i sensi con la gioia dell’altro con l’altro.
“Non aver paura di amare” dice Mina ad Helim allontanandosi, è un lascito vitale.
Vedi anche
Il caftano blu. Commento di Irene Ruggiero
I nostri libri (7 ottobre 2023). Report di Rodolfo Antonini
- Dettagli
- Categoria: Focus e Dintorni
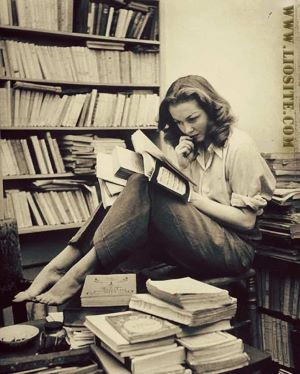
Giunto alla sua terza edizione, l’evento si è aperto con l’introduzione di Giuliana Rocchetti e Cristina Sarno sull’organizzazione e il senso della mattinata.
Il primo libro presentato è stato «Il diritto di esistere. Scritti sulla ricerca psicoanalitica di Lydia Pallier», a cura di Maria Grazia Chiavegatti e GianCarlo Di Luzio. L’attrice Luisa Merloni presta la sua voce al contenuto del libro con l’intento di evocare alcune suggestioni sui concetti caratterizzanti l’attività clinica di Pallier.
La prima lettura è sul tema della fusionalità: l’immagine è il sogno di una paziente che la vede protagonista insieme al suo analista; sono in automobile quando compare una terza persona avvolta da fumo denso. Tale figura sembra legarsi associativamente ad altre importanti figure del training dello stesso analista. «Il sogno attuale mi segnalava come la sognatrice percepisse a respirare, dentro di sé, attraverso l’esperienza analitica con me, l’effetto specifico di una presenza benevola condivisa, tutt’ora presente alle spalle di entrambi, che nel silenzio e nell’ombra, attraverso il respiro, nella sostanza fluida che diffusa ed inalata dagli altri passeggeri, li legittimava nella manifestazione dei loro stati interni». L’accento viene così posto sulla fantasia fusionale e sul contesto relazionale che tale fantasia implica, rispondendo contemporaneamente ai bisogni psichici di idealizzazione, gemellarità e rispecchiamento, condizioni ineliminabili per lo sviluppo di un Sé autentico.
Si transita poi per il costrutto del bambino mostruoso: «In molti pazienti alberga una fantasia molto angosciante, quella di un bambino che non ha diritto all’esistenza», rappresentato nei sogni da un bambino fatto da feci o urine. «La fantasia del bambino mostruoso è esattamente la rappresentazione dell’esperienza traumatica dal punto di vista del bambino» che si sente oscuramente insufficiente e non può sviluppare un Sé agente.
Si prosegue con la sindrome del millantatore: il fenomeno di sentirsi un bluff, di percepire l’inautenticità della propria identità, un vissuto invalidante l’autostima e la qualità della vita. Il paziente tipo è una donna attraente, di successo, di media età, intelligente e sensibile, che dimostra i suoi talenti a sé e agli altri. Sebbene questi le vengano riconosciuti, gli oggettivi successi placano solo momentaneamente il sentire di non avere valore e di non meritare il riconoscimento ottenuto.
Seguono gli estratti di alcuni capitoli, che offrono l’opportunità di entrare nella stanza di analisi della Pallier. «Non ha scritto molto, ma molto ha scritto nei cuori di chi ha analizzato […] o incontrato durante la formazione» La postura analitica dell’analista è definita come appassionata e intensa, tenera, ma dentro una cornice severa e rigorosa. Caratterizzata da silenzi e pause, quando timidamente si esprimeva un desiderio, lei taceva e si sentiva che era stata toccata profondamente da qualcosa; in quei momenti non esisteva alcuna interpretazione.
«La vita è più forte di tutto» è l’espressione che una sua analizzanda ricorda come «la rappresentazione di un suo modo di abitare il mondo e di stare in relazione con gli altri».
La conclusione è affidata alle parole di Lidya Pallier: «Penso che l’argomento di fusionalità ci venne in mente perché il gruppo lavorava in modo fusionale non comune. Un rapporto tra sé e oggetto-sé che portava al benessere e a sviluppare interesse».
Interviene Di Luzio che presenta i colleghi che hanno partecipato alla scrittura del libro: Carla Busato Barbaglio, Maria Grazia Chiavegatti, Gianfranco Giorgio, Alfredo Lombardozzi, Cristiana Pirrongelli, senza i quali il libro non avrebbe mai visto la luce.
Chiavegatti interviene soffermandosi soprattutto sulle teorie, facendo riferimento ai fenomeni di risonanza madre-bambino e alla fusionalità come a quell’humus necessario per sperimentare il senso di esistere. Il tempo dell’analisi dovrebbe permettere il ripristino delle funzioni del Sé. Orientamento, questo, che non è in contrasto con la teoria delle pulsioni, ma in rapporto figura-sfondo. Rivendica il ruolo centrale della fantasia inconscia quale anello di congiunzione tra psicoanalisi tradizionale e teoria intersoggettiva. Ricorda infine il gruppo di ricerca: Neri, Tagliacozzo, Petacchi e Soavi, oltre a Pallier, gruppo che ha lavorato in modo armonico, come un quintetto da camera.
Con i curatori dialoga Tonia Cancrini, la quale sottolinea come sia anche una giornata per ricordare Lydia. Precisa come il dolore della perdita non sia un lutto mortifero, ma una spinta a riprendere in mano le sue idee, sia teoriche che quelle nella pratica del suo lavoro, mettendo al primo posto il valore della vita e il diritto di esistere. Si sofferma sull’importanza delle prime vicende interne e della necessità di rielaborarle nel percorso analitico, in una dimensione dove prevale la condivisone e la tenerezza.
Seguono gli interventi dalla sala.
Qualcuno sottolinea gli aspetti positivi della fusionalità e il legame con la creatività, accennando alla permeabilità di Pallier nel farsi attraversare dalle fragilità e alla sua particolare ricettività inconscia. Qualcun altro si riferisce al libro come oggetto scritto e pensato sia per far conoscere i concetti teorici, sia per la possibilità di articolare tali concetti con le neuroscienze e l’Infant Research.
C’è chi ricorda il rapporto di Pallier con il silenzio e quanto questo non fosse una nostalgia legata all’assenza ma una presenza nostalgica. E chi informa come, oltre alla tenerezza, Pallier poteva essere arrabbiata rispetto a ciò che non le piaceva del mondo e della SPI con grande libertà. Proprio quest’ ultimo punto fa emergere il timore diffuso dei candidati a non avere diritti e si rivendica e legittima, invece, il diritto di pensare.
Infine, alcune sue analizzande evocano il ricordo delle proprie analisi di formazione e testimoniano come abbiano vissuto nella carne la fusionalità, di come tale esperienza vada oltre la parola scritta e faccia riferimento alla capacità dell’analista di sintonizzarsi sul tessuto psichico del paziente.
Ci si chiede se il lascito più importante non sia stato il passaggio dall’analista che sa alla co-costruzione analista-paziente.
Nella seconda parte della mattinata, Cristina Sarno presenta Ludovica Grasso, autrice del libro «L’inconscio sonoro. Psicoanalisi in musica». Si riflette sul ruolo della musica nella vita affettiva e psichica e sui meccanismi della ripetizione, dell’imitazione e della variazione. Gianni Garko, attore, presta la voce ad alcune pagine sul tema della sensorialità musicale descrivendo la moltitudine di suoni che si percepiscono nel quotidiano.
L’autrice propone la possibilità di fare un’esperienza. Partendo dall’ascolto di alcuni brani di Beethoven, Chopin, Bach, Schumann ed Erik Satie, si riflette sull’importanza del silenzio, sul tema della ripetizione come atto creativo e sul concetto di trascrizione e traduzione ricordando quanto l’azione dell’interprete sia fondamentale nel caratterizzare l’esecuzione.
Manuela Fraire interviene nella discussione proponendo come l’autrice, attraverso i casi clinici proposti nel libro, permetta di seguire il ritmo di ciò che accade nella relazione analitica, proponendo un’esperienza della lettura piacevole, dando l’impressione di ascoltare il libro. Citando Green «La musica è forse al di sopra della psicoanalisi, anzi penso ci sono cose che la musica riesce a esprimere e sulla quale la psicoanalisi non ha molto da dire. In più, mi sono convinto che ci sono analisti che amano la pittura e analisti che amano la musica. Non ci interessano le stesse cose. Suppongo che gli analisti che amano la musica, siano quelli per i quali, l’affetto ha una
dimensione essenziale e in nessun momento possono accontentarsi dei giochi di linguaggio e dei racconti, affascinanti. La musica incontra la psicoanalisi soprattutto nel ritmo, nel tempo, e nel fraseggio musicale».
Ultimo, il riferimento a due autori: Paolo Virno e Julia Kristeva. Il primo, con il libro «Quando il corpo si fa verbo», esprime come il suono preceda il linguaggio tanto da crearne la condizione. Il secondo autore ha scritto «La rivoluzione del linguaggio poetico», nel quale propone come il semiotico preceda il simbolico, non solo sul piano temporale.
Il secondo intervento è ad opera di Andrea Baldassarro che parte dalla premessa che le parole non riescano a coprire quello spettro di significazione che la voce riesce ad abbracciare. Afferma che il libro si inscrive nella tradizione psicoanalitica che sottolinea la preminenza della dimensione sensoriale su quella della parola e del linguaggio. Oltre alla centralità della sensorialità, nell’esperienza umana, troviamo una sorta di isomorfismo tra la musica e la psicoanalisi. Inoltre, sottolinea come l’ascolto analitico, andando oltre i contenuti e il linguaggio verbale, abbia molto in comune con quello musicale, centrato sul silenzio o sull’assenza, un ascolto del significante. Continua soffermandosi su due temi: il negativo e la ripetizione. Il primo presuppone che ci sia qualcosa che non c’è e si presenta in musica quando viene tolto tutto il rumore e i suoni che si possono togliere. Viene così ad emergere qualcosa, il positivo, che può essere una nota, un’armonia o un’interpretazione analitica. Il secondo, la ripetizione, introduce un cambiamento laddove non sembra esserci: le musiche di Steve Reich, compositore statunitense ispirato dalla musica balinese, sfruttano un sistema circolare di ripetizione, per il quale i suoni si susseguono in una struttura fissa con l’aggiunta di piccolissime e progressive variazioni.
Ludovica Grasso chiude la mattinata ringraziando profusamente e lasciando aperta un’importante domanda: «Cosa viene prima, la musica o le parole»?
Vedi anche
Altri articoli...
Powered by Multicategories for Joomla!2.5