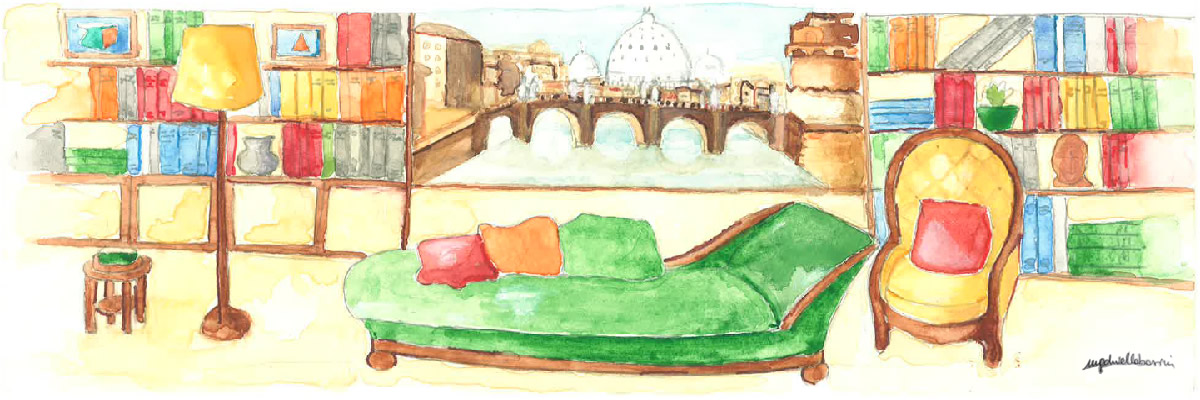Monica (Note di Mariaclotilde Colucci)
- Dettagli
- Categoria: Cinema e Psicoanalisi

Anno: 2022
Regista: Andrea Pallaoro
Sceneggiatura: Andrea Pallaoro, Orlando Tirado
Genere: drammatico
Durata: 106’’
“La psicoanalisi non pretende di stabilire che cosa sia la donna, compito che d’altronde non le compete, la psicoanalisi può solo esaminare come lo diventa”
Freud, 1933 [1]
“Donna non si nasce, lo si diventa”
Simone de Beauvoir, 1949 [2]
Monica, film del regista Andrea Pallaoro, prende il nome dalla protagonista, una donna che ha scelto e assunto su di sé le conseguenze della propria difficile e ingombrante scelta di essere e diventare donna. Dopo una lunga assenza, torna a casa per la prima volta ritrovando sua madre e suo fratello, dai quali si era allontanata da adolescente. Il tempo e il silenzio sono i suoi soli compagni di viaggio.
La storia si svolge prima in California, dove Monica vive sola, affranta dal dolore per un amore finito male e di cui si sa molto poco, e poi nel Midwest, dove si recherà chiamata dalla cognata al capezzale della madre. Il confronto con la malattia della madre la porta a riflettere sul suo passato e sugli effetti dell’abbandono. Il regista in modo delicato e profondo segue il percorso di affermazione di genere, che Monica intraprende nel suo dolore, nelle sue paure, nei bisogni e nei suoi desideri, fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le proprie e le altrui ferite. I pochi elementi narrativi vengano suggeriti con pudore e discrezione per provare a concedere ai personaggi la possibilità di ri-specchiarsi accettando il riconoscimento dei cambiamenti e delle trasformazioni.
Il corpo con le sue sensazioni è un altro elemento centrale del film in quanto luogo originario e costitutivo dell’identità e della costruzione del sé, ma anche luogo del cambiamento e della trasformazione. Il corpo esuberante e voluttuoso di Monica e il corpo dolente ed esile della madre morente fanno da contrappunto, in un tempo immobile che si dilata come per lasciare che in quella sofferenza ognuno possa riconoscere le tracce della propria umana specificità.
Monica è il terzo film di Andrea Pallaoro, dopo Hannah (2017), la cui attrice protagonista Charlotte Rampling si era aggiudicata la Coppa Volpi, e dopo il lungometraggio d’esordio Medeas (2013), ispirato alla omonima figura della mitologia greca, in cui al centro della narrazione c’è una donna. Il film è stato presentato nel 2022 alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in concorso per il Leone d’oro al miglior film e nel 2023 in concorso per il Queer Lion, Premio Suso Cecchi d’Amico per la sceneggiatura.
Come lo stesso regista ha dichiarato, attraverso il linguaggio cinematografico prende forma un ritratto intimo, tutto al femminile, in costante dialogo tra estetica dell’intimità ed estetica dell’alienazione, e in bilico fra l’interiorità della protagonista e il mondo che la circonda. Pallaoro e i suoi collaboratori si sono addentrati nel mondo emotivo e psicologico dei personaggi per riflettere sulla natura precaria dell’identità di ciascuno di noi, quando è messa alla prova dalla necessità di sopravvivere e trasformarsi.
In una società sempre più tesa alla complessità e caratterizzata da veloci mutamenti assistiamo, da un lato al ripresentarsi di nuove e violente forme di sistemi di valori e simboli, che sembravano appartenere al passato e che ripropongono, con modalità subdole, il controllo della sessualità femminile e del corpo delle donne, e dall’altro a nuovi percorsi di affermazione mobili e multiformi che riguardano e intersecano tra loro modelli di genere diversi, aperti a diffrazioni di identificazioni possibili e multiple, e di riappropriazione dei corpi e degli attributi sessuali e delle differenze, sulla base del proprio soggettivo sentire.
Oggi si celebra come ogni otto marzo la Giornata Internazionale dei diritti della Donna. È un momento importante per riflettere sui progressi compiuti nella lotta per l'uguaglianza di genere e per riaffermare l'impegno a eliminare le disparità, le discriminazioni e le violenze che le donne continuano a subire. Questa giornata ci ricorda che c'è ancora molto da fare per garantire un mondo in cui tutte le donne possano vivere liberamente e realizzare appieno il proprio potenziale.
L’antropologa Margaret Mead è stata la prima ad affrontare con le sue ricerche la differenza tra i sessi e soprattutto la differenza tra i ruoli sociali rinforzati da stereotipi culturalmente trasmessi e riprodotti. La tesi elaborata dall’antropologa americana auspica lo sviluppo di una società meno arbitraria e più ricca di valori contrastanti in cui ciascuna delle diverse doti umane trovi il suo posto, esortando al confronto con i tanti modi di essere uomini e donne contro i pregiudizi culturali che ostacolano ancora oggi la comunicazione tra i sessi, e la possibilità di fare scelte migliori per il nostro futuro:
“La nostra cultura, se la guardiamo storicamente, si è basata, per creare la ricca e contrastante gamma dei suoi valori, su molte distinzioni artificiali, la più sorprendente delle quali è il sesso. Non basterà semplicemente abolire queste distinzioni perché la società sviluppi dei modelli nuovi, nei quali le doti individuali possano trovare espressione, anziché essere costrette in forme non adatte. Se vogliamo elevarci ad una cultura più ricca - più ricca di valori contrastanti - dobbiamo accertare tutta la gamma delle potenzialità umane, e con essa fabbricare un tessuto sociale meno arbitrario, nel quale ogni diversa dote umana trovi il posto che le conviene”. (Mead, 1935)[3]
[1] Freud S. (1933) Nuove Conferenze sulla psicoanalisi. OSF, Boringhieri, 1973
[2] De Beauvoir S. (1949) Le deuxième sexe. Gallimard, Paris
[3] Margaret Mead (1935) Sesso e temperamento. Il Saggiatore, 2003