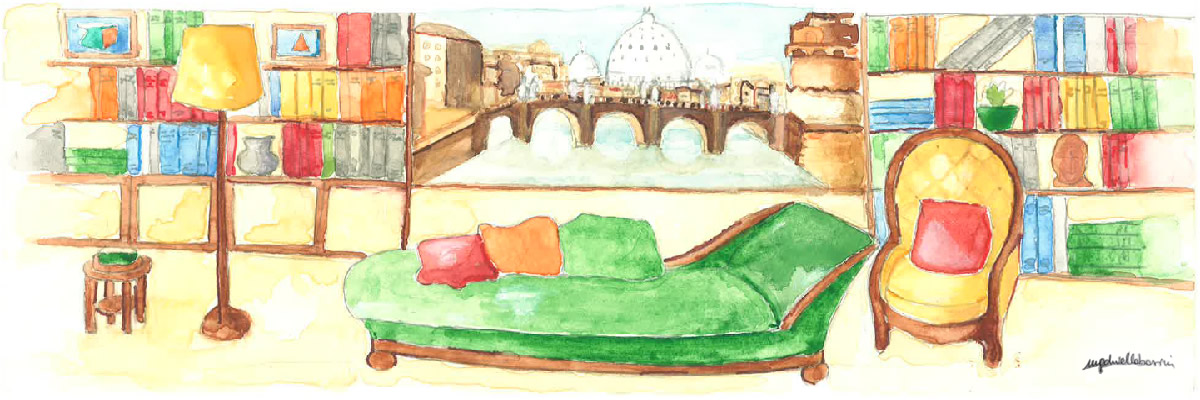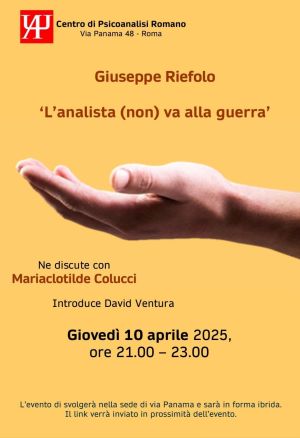

“L’analista (non) va alla guerra” (10 aprile 2025). Report di Francesca Fabiani
- Dettagli
- Categoria: Report eventi scientifici
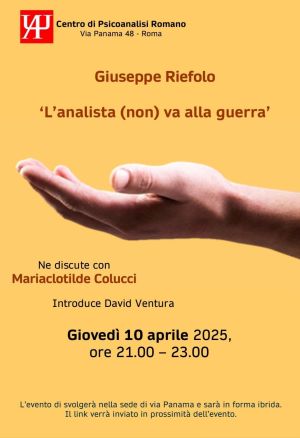
Nella serata scientifica del 10 aprile organizzata dal Centro di Psicoanalisi Romano, Giuseppe Riefolo presenta un lavoro dal respiro ampio e profondo e dal titolo evocativo: Lo psicoanalista (non) va alla guerra. Dinamiche della dimensione della tregua.
A seguire Maria Clotilde Colucci propone la propria riflessione sollecitata dalle tematiche emerse in questo lavoro.
La feconda discussione tra i due testi porterà poi ad un dibattito con la sala che parteciperà in maniera accorata e prolifica.
David Ventura, chair della serata, apre al primo intervento con alcune evocazioni prodotte dalla lettura del lavoro che richiamano subito il libro di Primo Levi in cui emerge il tema della tregua intesa come un tempo, una sospensione da un orrore, per ritrovare frammenti di umanità; un viaggio per trovare una dimensione temporale differente, in cui si possono iniziare a narrare le proprie esperienze.
Giuseppe Riefolo nel suo intervento ci presenta una riflessione originale sul concetto di tregua, non intesa come una semplice sospensione del conflitto, ma come uno spazio relazionale attivo e fertile, capace di aprire possibilità evolutive sia a livello interpersonale che sociale. Prendendo come modello della tregua la seduta analitica, l’incontro analitico tra paziente e analista — due estranei che si trovano insieme in una stanza senza conoscersi realmente — Riefolo sostiene che tale situazione configuri una dimensione in cui entrambi sono esposti a un’iniziale paura e disagio. Richiamandosi a Bion (1974), egli sottolinea come questa paura sia non solo inevitabile, ma necessaria per attivare dinamiche creative e trasformative.
Secondo Riefolo, la coesistenza forzata di due estranei genera un livello di frustrazione sufficiente ad attivare un processo dissociativo, che permette di modulare e restaurare la continuità del Sé, sia del paziente che dell’analista. Seguendo le riflessioni di Stolorow e Atwood (1994), questo processo riguarda esperienze che non sono state validate e che, senza integrazione, bloccano lo sviluppo affettivo. La tregua dunque si configura come uno spazio che permette di accogliere tali frammenti dissociati.
Giuseppe Riefolo approfondisce la nozione di tregua proponendo alcune tesi correlate che aiutano a comprenderla più a fondo, soprattutto in rapporto alla pratica analitica. A differenza della guerra e della pace — che seguono ciascuna logiche specifiche e incompatibili — la tregua è una condizione concreta, dotata di propri codici.
In questa prospettiva, la seduta analitica rappresenta emblematicamente questo spazio di tregua: un luogo fisico, condiviso, in cui l’obiettivo non è immediatamente discutere o risolvere, ma coesistere e accettare di incontrarsi.Riefolo sottolinea che a differenza dei rapporti sociali — dove spesso si cerca un accordo preliminare sui contenuti — nell’incontro analitico è sufficiente condividere un progetto implicito: avere fiducia in una organizzazione del Sé capace di ripristinare continuità dopo esperienze frustranti. La seduta diventa quindi uno spazio protetto che permette di accogliere anche conflitti o traumi non ancora elaborati. In questo senso, richiama l’idea di Bleger (1967) secondo cui il setting analitico può accogliere e contenere elementi non interpretabili, specialmente in situazioni molto regredite o violente.Riefolo insiste sul fatto che l’incontro è un obiettivo in sé, non solo un inevitabile passaggio.
Prima della relazione e del lavoro interpretativo, è essenziale che esista uno spazio in cui le parti possano semplicemente stare insieme, sospendendo l’attivazione delle logiche della guerra (dove entrambi hanno ragione e si scontrano simmetricamente) o della pace (dove si cerca il dialogo tra differenze). Nel contesto della seduta, la tregua permette di cambiare registro comunicativo e di rendere possibile l’attivazione di processi come transfert, empatia, identificazione ed enactment.
Riefolo descrive come il trauma congeli il pensiero e generi risposte automatiche (attacco, fuga, freezing), tipiche della guerra, bloccando l’incontro con l’altro. La stanza d’analisi, come spazio di tregua, permette invece la coesistenza fisica e l’attivazione di dinamiche specifiche. Queste sono la chimerizzazione, un processo in cui l’altro, inizialmente percepito come estraneo o minaccioso, può essere gradualmente integrato come parte di sé grazie alla fiducia che almeno uno dei partecipanti ripone nell’incontro. Accanto a questo, avviene un rispecchiamento imperfetto, in cui le risposte dell’altro, simili ma non identiche alle proprie, stimolano la costruzione di un sé più articolato e aperto.Fondamentale è anche la funzione del contesto in cui è la modifica dell’ambiente comune, più che la pressione sui contenuti, a consentire un cambiamento autentico delle posizioni. Infine, emerge una propensione al dono innata, per cui i soggetti — anche in situazioni di disagio — tendono spontaneamente a prendersi cura l’uno dell’altro, spinti da una logica di sopravvivenza cooperativa più profonda dell’interesse individuale. Queste dinamiche rendono la tregua un’occasione preziosa per contaminarsi reciprocamente e avviare, senza forzature, un processo di trasformazione condivisa.
Applicando queste idee ai conflitti sociali, come quello israelo-palestinese o russo-ucraino, Riefolo sostiene che prima di cercare un accordo o una pace, sia necessario creare spazi di incontro concreto, anche forzati, dove le parti possano coesistere fisicamente senza ancora affrontare le rispettive ragioni. Un esempio evocativo è il film Il viaggio (Nick Hamm, 2017), citato e presentato in un suo stralcio, per descrivere la coabitazione forzata di due nemici storici. Solo in questi spazi è possibile iniziare a trasformare le risposte automatiche e somatiche in processi simbolici ed empatici.
Perché la tregua diventi efficace, Riefolo indica tre condizioni operative fondamentali. La prima è introdurre una dimensione temporale, una distinzione tra passato e presente, aiutando i soggetti a riconoscere che ciò che li minaccia appartiene al passato e che il presente offre condizioni diverse. Esperienze ripetute in un contesto sicuro permettono di spezzare l’automatismo dell’allerta traumatica.
La seconda è assicurare la presenza di un altro soggetto affidabile, un testimone che dia continuità e sicurezza all’esperienza. Questo “altro” sostiene il soggetto nella fiducia che sia possibile aprirsi a qualcosa di nuovo, validando i vissuti ma anche orientando verso nuove prospettive.
La terza condizione è utilizzare contesti culturali e mediatori simbolici — come arte, sport o attività collettive — che consentano di trasformare la violenza e il dolore in esperienze comunicabili e condivisibili, riducendo la loro carica distruttiva e favorendo l’elaborazione.
In conclusione Riefolo suggerisce la costruzione di questi spazi di tregua, sostenuti da tempo, presenza e contesto simbolico, è la premessa indispensabile per disinnescare le risposte automatiche della guerra e per aprire alla possibilità di un dialogo evolutivo e di una trasformazione relazionale autentica.
Maria Clotilde Colucci presenta il suo intervento.
Nella sua discussione, riprende e valorizza la proposta di Riefolo sul concetto di tregua come spazio concreto e relazionale in cui due soggetti, anche estranei o in conflitto, accettano di incontrarsi. La tregua, dunque, è uno spazio intimo e accogliente che, pur percepito come potenzialmente pericoloso, si fonda su un atto di fiducia verso un percorso evolutivo.
Colucci sottolinea come questa tregua, modulando frustrazioni e dissociazioni, aiuti a recuperare la continuità del Sé. La paura legata al trauma si sposta da un ricordo del passato a un’anticipazione ansiosa del presente, mantenendo i soggetti in uno stato di allerta. Proprio per questo, analista e paziente sono coinvolti in un lavoro profondo di accoglienza dell’ignoto e del nuovo, sia a livello di pensiero che di esperienza emotiva e corporea. L’analista ha il compito di aiutare il paziente a transitare tra stati diversi di consapevolezza, facilitando passaggi non traumatici attraverso una responsività attenta e regolativa.
Colucci riconosce che si tratta di un lavoro clinico complesso, che sollecita fortemente l’analista e richiede una costante capacità di mantenersi aperti, ridurre l’angoscia e sostenere la mobilizzazione di blocchi psichici. La qualità della relazione analitica dipende non solo da una buona teoria, in accordo con la propria personalità, ma dalla capacità dell’analista di definire e modulare i confini tra tregua, pace e guerra, sempre tenendo conto dei mondi soggettivi di entrambi i partecipanti. In questo senso, il processo analitico non mira solo alla risoluzione di conflitti inconsci, ma a ristabilire la capacità di entrare in contatto pieno e autentico con gli altri.Riflettendo sui concetti di Riefolo (come ibridazione, chimerizzazione, rispecchiamento imperfetto e propensione al dono), sottolinea che essi richiedono la responsabilità individuale e collettiva di chi li mette in atto. La coesistenza e la collaborazione non sono mai date per scontate ma vanno continuamente costruite e sostenute. Si richiama qui alla funzione di testimonianza dell’analista che, come il testimone descritto da Donna Orange, offre una presenza che conferma l’esistenza e la vitalità del paziente, sostenendolo nel processo di costruzione di significati condivisi.
Colucci si interroga poi su come la proposta di Riefolo possa offrire una risposta agli scenari contemporanei segnati da distruttività, conflittualità e impoverimento della capacità di compassione reciproca. Riprendendo Bion e il concetto di scisma, evidenzia come i gruppi si difendano dal cambiamento attraverso divisioni che bloccano lo sviluppo. Cita anche Claudio Neri, che distingue tra speranza vaga e speranza operativa: la tregua proposta da Riefolo, nella sua dimensione concreta di coesistenza e scambio, può incarnare proprio questa speranza attiva, aprendo la possibilità di suggerire al paziente — e forse anche alle società — che le cose potrebbero andare diversamente da come si teme o si immagina.
In conclusione, evidenzia della proposta di Riefolo una prospettiva preziosa per la clinica e per il pensiero psicoanalitico, capace di offrire uno spazio concreto per la costruzione di rapporti nuovi e vitali, fondati sulla fiducia e sulla comprensione reciproca.
A seguire la partecipata discussione con i presenti in sala e online porterà riflessioni e domande che si alternano tra le questioni più psicoanalitiche e la drammatica situazione attuale in cui i temi della paura dell’incontro con l’altro inevitabile e necessaria per fare la tregua, il tema della testimonianza e della tregua come attesa, sollevano considerazioni e risposte da parte dei relatori.