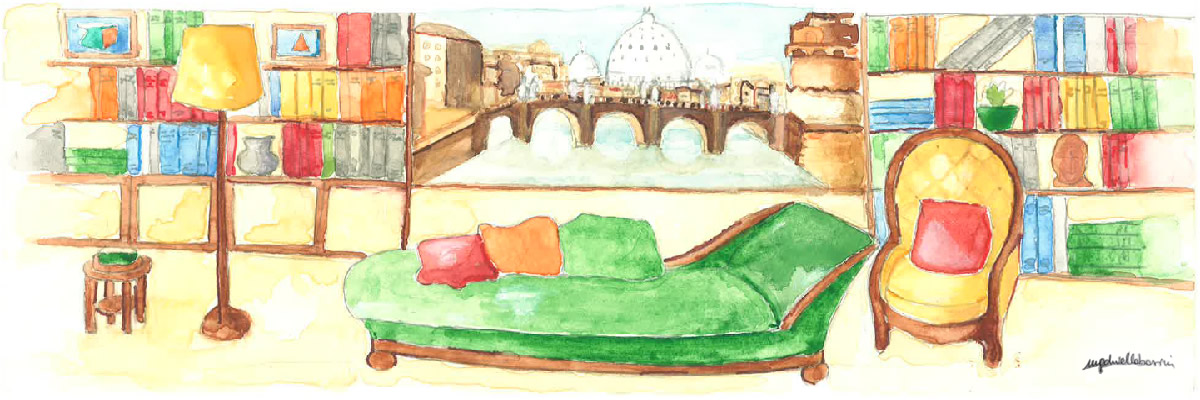Oggetti d’amore, oggetti d’odio: violenza e follia nei legami fra i sessi (9 novembre 2024). Report di Valeria Gubbiotti
- Dettagli
- Categoria: Report eventi scientifici

Il 9 Novembre 2024 si è svolto il convegno intercentri “Oggetti d’amore, oggetti d’odio: violenza e follia mei legami tra i sessi”.
In questa interessante giornata abbiamo riflettuto su quali siano le condizioni che consentano di incontrare e tollerare l’altro e sui fallimenti di tale riconoscimento, i cui esiti possono talora diventare catastrofici. Come ci hanno ricordato i relatori la follia, gli eccessi, gli sconfinamenti, le necessità di dominio nei legami d’amore prendono forma in una comunità che ha messo in dialogo profondo, talvolta conflittuale, sessualità e genere, maschile e femminile, paterno e materno. Una complessità della contemporaneità che ha largamente arricchito la possibilità di espressione della soggettività, ma al prezzo di perdere in sicurezza e in stabilità di sé.
Fabio Castriota, chair della giornata, presenta i relatori.
Tiziana Bastianini nella sua relazione pone degli importanti interrogativi: a quale prezzo diventiamo quello che siamo? Quali sono le condizioni di crescita che permettono ad un individuo di riconoscere l’altro come fonte di arricchimento e di piacere? In quali condizioni siamo sopraffatti dal terrore dell’annichilimento evocato dall’altro che è diventato un nemico? Che cosa gli uomini e le donne desiderano gli uni dagli altri? Dobbiamo continuare a porci interrogativi ed esplorare lo spazio dei legami d’amore al fine di comprendere sempre più in profondità i meccanismi del dominio e del possesso come risposta all’intollerabilità della separatezza e dell’incontrollabilità degli oggetti.
La gelosia e la rabbia pervasiva provate tra partner sono espressione dell’angoscia di perdere con l’amato o l’amata una parte del sé sia scissa e confusa nell’altro. Questa esperienza psichica intollerabile può essere contrastata in fantasia con “eliminazione” dell’altro, in quanto fonte di sofferenza, per riappropriarsi così di un frammento di vita psichica che non si può lasciare andare. Allora una coazione incoercibile, che non da pace e che genera la profonda umiliazione di essere stati esposti allo scacco dell’altro, dà origine alla convinzione che cancellare fisicamente il nemico è un modo di cancellare con lui il potere sulla nostra vita. Questa distorsione patologica dei legami d’amore prende forma a partire dal crollo dello spazio psichico tra sé e l’altro, in cui l’unica forma di legame possibile può condurre a far precipitare l’originario amore in rabbia e odio tirannico verso chi ci fa soffrire. La tendenza a rintracciare negli altri solo il riflesso del proprio sé è il seme del dominio: più l’altro è soggiogato e dominato meno è vissuto a livello umano dotato di una propria vita psichica. Tale pericolosa dipendenza deve poter essere controllata in una spirale di violenza che non può riconoscere all’altro la funzione di limite e di confine.
L’altra faccia del dominio riguarda l’incapacità delle donne di riconoscersi e di riconoscere l’oggetto cattivo e di dotarsi di alcuna funzione protettiva. Negare l’esistenza dell’oggetto cattivo, che non può essere riconosciuto come tale, ha origine remota nella storia del soggetto che vincola ad un accecamento psichico se lo sguardo dell’altro non ha riconosciuto e non è stato interiorizzato come fonte di protezione.
La questione paradossale allora è che in ogni legame sperimentiamo l’altro fuori dal nostro controllo onnipotente e contemporaneamente abbiamo un bisogno estremo che lo sia. Ma allora, quale è il rapporto tra desiderio e riconoscimento? Come imparare a fare i conti con le differenze e tollerare questi paradossi? Come è possibile continuare ad essere sé stessi riconoscendo all’altro, dal quale non possiamo separarci, un’esistenza psichica autonoma, se non al prezzo di patire un enorme dolore? Come è possibile evitare la scissione e il crollo del riconoscimento?
Winnicott insegna che quando il ruolo della madre non è pienamente riconosciuto resta un timore della dipendenza e questo timore si trasformerà in paura della donna, in altri casi assumerà aspetti meno immediatamente riconoscibili ma resterà costante la paura di essere dominati. L’elemento di dipendenza insito nel desiderio ripropone inevitabilmente le vicissitudini della propria dipendenza infantile. Questo tipo di esperienza può sempre porre il soggetto lungo il crinale dell’umiliazione e della rabbia ed è per questo motivo che l’oggetto d’amore può trasformarsi repentinamente in oggetto di odio. Il femminile che eccita costantemente un desiderio o stimola il bisogno di una dipendenza assoluta è un fantasma contro cui la mente maschile, che percepisce la donna come dotata di un potere che lo rende passivo e succube, combatte in molte forme del legame.
Ma come mai alcuni uomini fanno esperienza del desiderio di una donna in termini di una dipendenza sprovveduta, annichilente, umiliante?
Con l’espressione “Resistere al materno” Tiziana Bastianini descrive la battaglia continua nell’individuo nel differenziare i fatti dalla fantasia, la realtà esterna dalla realtà interna, il mondo dal sogno, ed è in questa lotta che prende forma la capacità di riconoscimento del primo altro da sé, la madre. Questo delicato equilibrio, su cui poggia la base del sentimento del proprio valore, è in costante oscillazione e mostra segni di frattura quando le difese narcisistiche del sé hanno la funzione di preservare la struttura psichica dal dolore mentale non pensabile.
I pazienti che soffrono di una incapacità di amare, di costruire e di mantenere legami intimi e duraturi vivono con terrore ogni dipendenza e questo è l’elemento speculare della necessità di dominio. Una dipendenza fuori controllo in cui si perde ogni legame intimo e profondo con l’altro e che racchiude un’oscura minaccia da cui rifuggire. Tale organizzazione narcisistica non è fondata sul rifiuto orgoglioso della dipendenza quanto sulla mancanza di oggetti affidabili da cui poter dipendere. Una trasformazione evolutiva proposta da Andrè Green quando gli oggetti sono stati precocemente delusivi e al soggetto non rimane che affidarsi, per compensazione, alle risorse illusorie della propria onnipotenza.
La parola passa a Manuela Fraire: ad averla colpita è il punto sottolineato da Tiziana Bastianini riguardo l’intimità, come questa cambi nel momento in cui cadono le leggi che regolano il rapporto tra i sessi, che sono le stesse leggi della maternità e paternità nell’ambito della famiglia.
Oggi gli uomini, che non si riconoscono nei mutamenti contemporanei e che mostrano il disagio di identificarsi in un nuovo ruolo sociale, di fronte al crollo di tutte le identificazioni primarie maschili e femminili sono “muti”. Quando “parlano” sembra che debbano urlare attraverso la guerra o il femminicidio e questi uomini non sono solo i compagni ma anche i figli del silenzio dei padri.
Le differenze con il femminile inducono dei movimenti difensivi sotterraneamente animati da rancore che sembra nutrirsi ed essere alimentato da un sentimento di invidia, che può sfociare anche in agiti verso l’altro sesso. L’oggetto d’odio è anche oggetto di una inconfessabile invidia per qualcosa di fondamentale con cui la donna affronta la vita. Manuela Fraire definisce “più di vita” ciò che ha a che vedere con l’intimità di cui parlava Tiziana Bastianini, e che riguarda la capacità della donna di sostenere il contatto tra “corpi parlanti”.
Alla base della violenza di genere sembra lavorare un’oscura consapevolezza che la donna sia ricettacolo di un bene, quel più di vita, che al significante fallico sarebbe stato negato o sottratto. A differenza dall’invidia del pene, il maschio non ha il possesso di qualcosa, ma vive l’angosciosa condizione dell’essere ora il derubato.
Da dove viene questo “più di vita” che le donne hanno e di cui gli uomini anelano il possesso? La nostra specie ha una pulsionalità verso l’altro non legata solo alla riproduzione della specie e questo è un punto cruciale. Le donne sono meno esplicitamente aggressive rispetto agli uomini, ma lo sono con le parole che possono essere usate come pietre. Hanno una maggiore potenza dialettica e discorsiva perché usano il linguaggio per comunicare; gli uomini, al contrario, sono più limitati da una legge che dice che quello che comunicano non deve avere con le loro emozioni un rapporto diretto e che le emozioni devono essere lavorate in una maniera che l’uomo non risulti in balia di qualcosa che la razionalità non può governare.
Il fatto che gli uomini non abbiano gli strumenti per parlare di ciò che sentono si trasforma nella mente di molti di essi, sin dalla nascita, in qualcosa di temuto in relazione all’altro sesso, connesso a fantasie di passività e impotenza. Le donne racchiudono nel corpo il mistero della procreazione e della parola che lega alla vita: un uomo deve avere un’autorevolezza nella mente di quella donna che non è più oggi quella del patriarca. Questo è un punto forte.
Come può avvenire allora che degli uomini possano ritrovare dentro di sé quel saperci fare con la vita che attribuiscono alle donne?
Piera Aulagneir parla del “portaparola” riferendosi alla parola messa a disposizione dalla madre e dallo psicoanalista nel momento in cui si propone una messa in forma di quelli che sono gli scambi primari che avvengono tra un adulto e un bambino. Questa parola è il “più di vita” che le donne stanno creando da secoli di vicinanza con il neonato e con l’impotenza originaria. Ognuno di noi nasce letteralmente nelle mani dell’altro e dobbiamo sperare che queste ci siano e che siano affidabili. La dipendenza è come un’impronta digitale ci segue per tutta la vita perché ogni volta che ci sembra di non poter affrontare le situazioni che ci stanno intorno, sentiamo di essere nelle mani dell’altro. Oggi anche molti uomini fanno esperienza della dipendenza assoluta alla nascita nel neonato e con i loro bambini piccoli: che la funzione materna trasmigri sul padre non è affatto una novità eppure c’è qualcosa che manca, cioè una pratica discorsiva degli uomini che è il modo di trasformare le emozioni in intimità che si vive con gli altri corpi. Questo significa anche avviare una narrazione che non ha solo un presente ma anche un futuro.
La relazione di Alessandra Balloni stimola riflessioni sugli “abissi del dualismo” attraverso alcuni esempi clinici intrecciati a suggestivi e ricercati riferimenti letterari. Nell’idiota di Dostoevskij viene descritto il carattere contraddittorio dell’essere umano: i due protagonisti, Parfen Rogozin e il principe Myskin, rappresentano l’amore sdoppiato e descritto nei suoi estremi limiti: l’abisso incarnato nel desiderio tormentato e possessivo e la compassione rappresentata dalla purezza incorporea dell’animo. Questi personaggi ci conducono al cuore del convegno e alle forme dell’amore e dell’odio che possono generarsi nei legami: il possesso, il dominio la passione e la dicotomia dell’essere umano. Siamo alle prese con la continua oscillazione di esigenze di segno opposto e difficilmente conciliabili: da un lato la ricerca di una alterità perfettamente in sintonia che non può tollerare l’alienità, dall’altro l’amore nella totale libertà sebbene decentrato da sé e dai propri bisogni. Nei casi in cui il delicato e doloroso percorso evolutivo verso la soggettivazione non ha mai avuto luogo, la rottura del legame unilaterale che il soggetto sente di subire come una condanna, può dare luogo ad un collasso del sé che rievoca traumi originari che si sottraggono ad una possibile significazione. La perdita dell’oggetto investito narcisisticamente risveglia un odio distruttivo che il soggetto rivolge anche verso sé stesso e, non potendo elaborare il lutto, si ostina ad alimentare un investimento ambivalente.
Ma allora, in questi casi quale funzione di rispecchiamento dell’immagine maschile le donne assumono? Quale ideale del sé coltivano gli uomini attraverso lo sguardo femminile? Cosa accade quando lo specchio si infrange? Perché il venire meno di questa funzione che innesca conseguenze catastrofiche? In considerazioni sul rispecchiamento del 1907 Freud parla della fantasia di liberarsi di una madre onnipotente e del suo arcaico dominio. Nel primo caso clinico presentato viene illustrato molto bene come questi aspetti emergano nella dinamica transferale.
Un’altra paziente porta con sé con un passato traumatico segnato da precoci lutti, violenze, deprivazioni e un presente di caos e costante senso di pericolo. Solo dopo molti anni di matrimonio realizza l’alcolismo del marito riuscendo a comporre il puzzle di una narrazione frammentata.
Orwell in “1984” descrive una struttura di governo basata sul bi-pensare, necessaria al mantenimento in vita del regime. Si tratta di un’organizzazione mentale in cui la lucida manipolazione della realtà convive con l’adesione ad una realtà manipolata e tuttavia non viene percepita come tale. Il bi-pensare implica la facoltà di avere allo stesso tempo nella mente due convinzioni contraddittorie e di accettarle entrambe. Questa organizzazione interna, così come nel caso clinico presentato, opera difensivamente come esito della progressione traumatica nell’adulto. In questi casi il distacco dal sentire emozionale opera un pervasivo e diffuso scollegarsi dall’esperienza emotiva sia con il mondo esterno che con quello interiore. Il rifugio della paziente non costituiva un ponte con la realtà ma rappresenta una difesa dissociativa della paziente che le permetteva di fuggire.
Nel ricchissimo dibattito sono stati particolarmente apprezzati gli interventi, creativi e fuori dai soliti circuiti di pensiero e di ragionamento quando si affrontano questi argomenti di confronto tra maschile e femminile.
Un’insegnate presente in sala sottolinea come nella scuola sia molto presente il “più vita” del femminile: le bambine sono più attente, riflessive e capaci dei bambini maschi, che appaiono iper-protetti dalle madri. L’iper-protezione dei figli maschi, attraverso cui spesso la madre recupera l’amore che non ha avuto dal compagno, genera dei ragazzi mancanti dell’autonomia e della parola.
Le donne devono fare molto per lavorare sulla loro capacità di sostenere i processi separativi e la diversità. Se anche gli uomini, dall’altra parte, imparano ad affrontare la diversità devono accettare di essere mancanti di “qualcosa” come anche le donne lo sono. Questa mancanza non necessariamente deve caricare di invidia e del desiderio di annullamento, ma anzi può arricchire perché ci sono dei passaggi umani nel sé, nel profondo sé del maschio e della femmina, molto importanti.
Un altro punto importante è che nel processo di svincolo e soggettivizzazione, l’uomo non può ricorrere all’identificazione con il corpo della madre, cosa che può fare invece la bambina. Questo pone una questione seria nell’evoluzione psicosessuale dell’uomo. La generale mancanza di modelli di identificazione maschili, ad esempio anche il corpo insegnate è quasi completamente femminile, pone un altro grosso problema.
Maschi e femmine non sono diversi nei Tre Saggi di Freud, vengono entrambi dalla neutenia: nasciamo troppo in anticipo e non possiamo sopravvivere senza la protesi di un adulto che ci fornisce le soluzioni che lentamente integriamo dentro di noi attraverso le funzioni di cura. Ciò che tutta la vita continuiamo a fantasticare è di poterci arrendere finalmente nelle mani dell’altro, che tiene alla nostra vita e non solo alla propria. Le donne, che prendono parola e incarnano il più di vita, sono allenate a superare la paura della dipendenza per amore dell’altro perché hanno in mano la cura dei neonati. Al contrario, non pensiamo che sia possibile affidarci così nelle mani di un uomo a meno che non sia una figura istituzionale, come il medico.
I relatori ritornano sul maschile e femminile come necessita di mantenere continuamente l’idea di complementarità, che dovrebbe contrastare la polarizzazione di genere per far lavorare diversi livelli del funzionamento psichico. Le identificazioni preedipiche offrono molte possibilità del futuro sviluppo di un’organizzazione psichica capace di non polarizzarsi. Queste hanno, infatti, molta più possibilità di espressione dei vari elementi del maschile e del femminile di quanto non possano esprimere le identificazioni edipiche, che richiedono una convergenza con il proprio sesso per assumere una serie di funzioni di ruolo. Sono questioni molto complesse in questo periodo storico in cui le identificazioni edipiche non sono più così lineari. Lo sforzo enorme deve essere allora nella direzione di tenere insieme nella mente, ma anche sul piano teorico, l’integrazione tra livelli pre-edipici e la transizione edipica, come questi dialogano e come ritornano gli uni agli altri. Quando la psiche sarà in grado di sentirsi portatrice di elementi maschili e femminili, sarà possibile un dialogo in una forma rispettosa.
Si riprendere nel pomeriggio con la relazione di Maria Serena Sapegno, docente di Letteratuta Italiana e Studi di Genere alla Sapienza di Roma, che propone delle stimolanti osservazioni sull’attualità.
La cronaca manca di una piena una consapevolezza diffusa dei rapporti violenti tra i sessi. Poco si conosce della dimensione implicita degli stereotipi che passa attraverso una trasmissione inconsapevole, pertanto ancora più potente. La morte di Giulia Cecchettin o il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi colpiscono per la “normalità dell’accaduto” rispetto alla narrazione, con cui si vuole escludere ogni patologia nel comportamento del giovane omicida o ricondurre tutto ad una inquietante, ma “normale” normalità. Questa qualità della narrazione, che quasi acquisisce i toni della provocazione, colpisce nel profondo: l’uomo non è “matto”, ma un figlio sano del patriarcato.
Oggi assistiamo a un lento cambiamento della coscienza collettiva e a una mutazione nei rapporti tra i sessi rispetto alla generazione nata tra gli anni 20/40. Le donne nate e cresciute durante il fascismo ricevevano messaggi ambivalenti: studiavano ed uscivano di casa, ma rimanevano condannate a fare figli e a vivere in una struttura patriarcale. Avevano imparato a sviluppare un potere materno e ad evitare ogni scontro usando la manipolazione e l’inganno, perché non c’erano altre strade. Oggi il modello implicito delle ragazze le rappresenta come oggetto sessuale da curare ossessivamente per aumentarne l’attrattività ed il valore, come studiose, affidabili, responsabili eppure allo stesso tempo la donna è indifesa e inerme in stato di pericolo, bisognosa di protezione. Un insieme di realtà contradditorie da tenere insieme, tutte nello stesso faticoso momento. Al contrario il modello di libertà è quello maschile che prevede la carriera e soprattutto l’autonomia economica, in cui la mascolinità è spesso ricondotta alla ricerca del successo che non si costruisce con lo studio e la preparazione.
Le ragazze vanno avanti negli studi il 10% in più rispetto ai ragazzi. Sono molto più colte dei maschi, che mantengono un atteggiamento conservatore e reazionario. Questo pone un contesto di carenza di interlocutori. La crescente sfiducia reciproca porta a coinvolgersi più tardi nelle relazioni sessuali di quanto accadeva nelle generazioni precedenti e molti giovani maschi vedono, difensivamente, le donne come una minaccia e un freno alla loro carriera. Connesso a questi dati fa riflettere che nella generazione Z, i nati tra gli anni ‘90 e 2000, si hanno relazioni tra donne in numeri doppi rispetto alle generazioni precedenti.
Per tanto è importante che impariamo ad accettare che il conflitto tra sessi è inevitabile e necessario, dialettico e non violento. Ancora oggi le donne nei centri anti-violenza hanno difficoltà ad identificare la violenza come tale, a prenderne le distanze e a concepire il proprio diritto a sottrarsi anche in assenza di figli, così come anche i maschi fanno fatica a riconoscere la propria aggressività fuori controllo.
La relazione di Mariaclotilde Colucci ci consente, attraverso tre efficacissime vignette cliniche, di entrare nel cuore del lavoro con pazienti implicati in legami violenti. Il titolo della relazione “bagno di sangue” è una metafora potente nel farci sentire l’intensità con cui queste relazioni comincino con una grande complicità e intesa sessuale e si concludano, poi, in situazioni violente e fuori controllo.
Sono descritti tre uomini con difficoltà ad amare e desiderare l’altro, di cui la soggettività viene continuamente disconosciuta. I legami tra partner entrano in crisi quando emergono i desideri delle compagne, come ad esempio quello di avere un figlio. Attraverso questi uomini violenti, ma anche estremamente fragili, sono ripresi i temi trattati nella mattina- l’intimità, la vicinanza, il sentirsi al sicuro, i limiti, i rischi dell’incestuale- calati nella clinica. Le vicende emotive e relazionali, con le loro ricadute nella dinamica transfert/controtransfert, sono ben descritte nei sogni dei pazienti e dell’analista. Mariaclotilde Colucci sottolinea come in ciascuno di noi ci siano dei residui di sessualità infantile dissociata che può prendere una forma nei contenuti onirici.
Flavia Salierno propone alcune clip video di “Gastlight”, un film del 1944 di George Cukor. La pellicola racconta della relazione tra Gregory e Paula e di come lui riesca a convincerla attraverso una sottile ma continua manipolazione di essere pazza. Paula stessa finirà per credere in questa follia.
L’uomo sembra “entrare” progressivamente nel cervello della moglie facendola dubitare delle proprie percezioni. Le clip proposte ci permettono di osservare quali siano le modalità di relazione patologiche e perverse attraverso cui il partener distorce la realtà dell’altro con effetti devastanti nella sua mente. Il modello di manipolazione relazionale descritto è finalizzato alla soddisfazione dei propri bisogni e al controllo assoluto. Gregory non può accettare l’individualità di Paula e usa la moglie per mantenere il sé coeso: fa pagare all’altro il prezzo della propria angoscia di frammentazione.
Dal punto di vista di Paula la dipendenza affettiva patologica esprime il bisogno di essere accettata e amata. La donna ha un passato di lutto e solitudine trasferisce su Gregory il centro della sua vita affettiva; proiettando sul marito protezione e forza, in modo molto idealizzato, e celando un vuoto narcisistico e l’incapacità di vedersi in modo autonomo. Questa dinamica la porta a subire abusi senza riuscire a reagire continuando a perdere progressivamente la propria autonomia, tollerando ogni umiliazione e controllo. La dipendenza affettiva appare come una difesa da un profondo timore dell’abbandono e la paura di essere lasciata o respinta inibisce ogni tentativo di affermazione personale.
Vedi anche
Oggetti d’amore, oggetti d’odio: violenza e follia nei legami fra i sessi (9 novembre 2024)