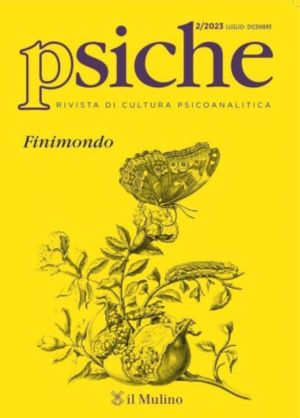

Rivista di Cultura Psicoanalitica “Psiche” – Finimondo (12 settembre 2024). Report di Simona Pranzitelli
- Dettagli
- Categoria: Report eventi scientifici
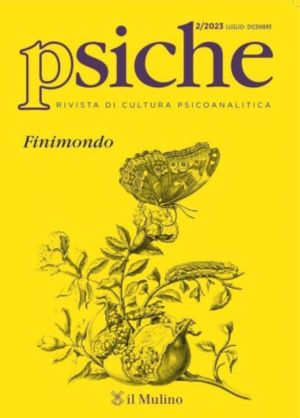
La Psicoanalisi non è innamoramento
ma è trasformazione dell’innamoramento,
trasformazione degli affetti in linguaggio.
Franco Forna
Alessandra Balloni, chair della serata scientifica promossa dal Centro di Psicoanalisi Romano (CdPR), presenta Stefania Nicasi, attuale direttrice della Rivista Psiche, e Lorena Preta ed Enrico Pozzi, due tra gli autori che hanno maggiormente contribuito al ricco volume “Finimondo”.
L’evento ha come auspicio l’obiettivo di trasmettere la cultura e l’ereditarietà psicoanalitica ed il legame delle origini di Psiche con il Centro di Psicoanalisi Romano poiché, come dirà Bonanome, “la storia e la memoria trasformano il fare dello storico in fare del cittadino”.
Nicoletta Bonanome, redattrice e caporedattore di Psiche dal 1993 al 1996, omaggia la serata con una nota introduttiva sulla nascita della rivista raccontando le origini e la caducità del portare avanti la stessa. “Ricordare è un ri-accordare: la nostra vita è legata a chi ci ha lasciato e a come riusciamo ad attivare cambiamenti e trasformazioni, dunque il ricordare produce la costruzione”. Dobbiamo a Paolo Perrotti la fondazione di Psiche nel 1948 come bollettino dell’Istituto di Psicoanalisi di Roma, con sede in via Salaria 237, che la diresse fino al 1971. L’idea della rivista verteva sul far conoscere gli aspetti psicologici della vita sociale e denunciare, al contempo, il sistema di credenze condivise che aveva governato l’epoca precedente, sostenendo ideali che potevano circolare nuovamente. Vi era infatti la necessità di un tessuto connettivo che aiutasse a dialogare, non per affermare le idee psicoanalitiche, ma per articolare il modo in cui le stesse venissero adoperate.
Verso fine anni ‘80, grazie ad A. Traverso, P. Perrotti e R. Tagliacozzo iniziò una battaglia per dare “nuova vita” a Psiche. Perrotti, sotto la presidenza di Tagliacozzo, regalò alla SPI la nuova rivista che doveva essere considerata come sorella della Rivista di Psicoanalisi: Traverso fu il caporedattore e ci furono 80 redattori per settori tematici diversi. Perrotti voleva permettere di far navigare ancora nel tema dell’incertezza con l’obiettivo di costruire un Laboratorio Psicoanalitico di incontro e di ricerca che permettesse di sentirsi parte di una “casa comune”, ma l’impresa durò due anni a causa della morte di Traverso. Per mesi la rivista rimase con un destino di sopravvivenza incerta, Perrotti anche si dimise. Nel 1995 Tagliacozzo decise di raccogliere l’eredità di Psiche modificando la struttura editoriale in una dal carattere monografico: A. Ferruta e N. Bonanome furono le caporedattrici e il comitato di redazione fu formato da 10 psicoanalisti che trattarono le problematiche della relazione, le domande e le risposte fondanti il Sé, il concreto e il pensabile.Tagliacozzo aveva in mente il modello di una comunità multilingue, una specie di democrazia della mente. La morte di Tagliacozzo creò però un ulteriore “finimondo”, tema nuovamente attuale ai giorni nostri.
Stefania Nicasi ricorda gli intenti con cui Perrotti fondò Psiche e spera di riuscire a mantenerli tutt’ora vivi: “Stimolare la curiosità, vincere la pigrizia mentale, dirottare le correnti abitudinarie nei confronti del pensiero”. Nicasi racconta che Psiche cura minuziosamente la scelta delle parole per i titoli dei numeri e dei capitoli nell’intento di fungere da “guide alpine” per i lettori, unitamente alla scelta altrettanto accurata della grafica, grazie anche alla casa editrice Il Mulino. In particolare, i fiori e le farfalle del numero “Finimondo” interpretano lo spirito del fascicolo: essi trionfano sui bruchi e sul frutto spaccato, suggerendo così un movimento, insinuando nell’idea della “catastrofe del finimondo” che la fine di qualcosa può essere l’inizio di altro. La parola “finimondo” ci aiuta ad affacciarci sul buio dell’abisso gettando però un fascio di luce: essa punta infatti ad un alleggerimento del tema rispetto a “la fine del mondo” o “l’apocalisse”, volgendo il crollo in cambiamento e la morte in nascita, un principio di speranza che mai dovrebbe abbandonarci quando guardiamo alla storia del mondo e quella dei pazienti. Vi è nel volume un’idea di processo, di mutazione, di dinamicità. Il numero è da considerarsi “anti-apocalittico” nel senso che, pur essendo consapevole dei rischi e delle tragedie che stiamo attraversando, è curioso del mondo che verrà. L’esperienza della caducità percorre tutta la vita, compresa, come abbiamo visto, la vita di Psiche: il volume tratta anche questo tema poiché vi è la tendenza a proiettare nel mondo esterno ciò che accade nel mondo interno. È importante, però, dice la caporedattrice, “consegnare anche ai giovani un mondo positivo, continuare a credere nella primavera e nel suo slancio”. Nicasi conclude il suo intervento mettendo in luce positivamente l’importanza del pensiero di una fine poiché ciò reca sollievo, aiutando a sopportare i momenti difficili, la noia e il dolore. Primo Levi diceva che “la gente è protetta e sostenuta dalle stesse cose che la rendono vulnerabile” alludendo all’insufficiente conoscenza del futuro che lascia spazio alla speranza, alla sicurezza della morte come mezzo per porre fine alle sofferenze e alle cure materiali che ci tengono occupati distogliendo la nostra coscienza da quello che sta accadendo attorno a noi.
Lorena Preta, direttore di Psiche dal 2001 al 2009, nella rubrica “Calma Piatta” afferma che “il mondo finisce laddove diventa troppo semplice e piatto” ovvero il mondo degli apocalittici è contrassegnato dalla scomparsa della complessità e delle contraddizioni. Sempre più oggi giorno ci confrontiamo con ritmi che saltano e tradizioni che scompaiono. Prima era possibile individuare cesure, passaggi, fare esperienze più o meno definite mentre, nel tempo presente, sentiamo piuttosto di subire cambiamenti inaspettati o sfibranti prolungamenti che creano un senso di allarme non pacificante per il corpo e per la mente. Le nostre certezze sono sempre più scosse e occorre attuare un processo di negazione per garantire familiarità all’apparato socio-culturale al fine della consueta organizzazione sociale. Oggi le immagini si moltiplicano, le conoscenze anche, ma sembra non ci sia un contenitore adatto a lavorarle per trasformare i vissuti e le esperienze, facendoci rimanere costantemente in balia degli eventi. Il senso di impotenza è spesso costante e la speranza di azioni efficaci lontana. Siamo indifesi e confusi, facciamo i conti con mutazioni antropologiche. Si percepisce una sorta di incongruenza tra passato e presente: i tempi slittano gli uni sugli altri e non si riesce a cogliere il collegamento all’origine e farne una fonte preziosa per il presente. Nella scena mondiale attuale, fatta di guerre o contesti conflittuali, domina la rivendicazione identitaria; il collegamento passato-presente oggi si potrebbe definire di tipo allucinatorio, come se il passato fosse presente ma senza aver subito nessuna trasformazione: ne deriva che il futuro è svuotato di garanzie di cambiamento in senso evolutivo, come invece dovrebbe essere. Le carenze della funzione simbolica rendono la realtà non pensabile ma dominata dall’azione, dalla pratica della dispersione, dalla violenza senza scopo. Preta nota nel lavoro clinico che oggi si fa fatica a trasferire nell’inconscio le esperienze fatte durante la veglia, mentre per Bion ciò rappresenta la garanzia della trasformazione psichica. Bisognerebbe trovare una trasformazione vitale alle forme sociali, permettere il ricomporre della catastrofe e crescere, “apprendendo dall’esperienza”, anziché promuovere un “furioso inferno di avida inesistenza” (Bion).
Enrico Pozzi, con il contributo intitolato “Fino all’ultimo respiro”, ripercorre la terribile vicenda del suicidio di massa del 1978 in Guyana mettendo in luce un ulteriore risvolto della dialettica fine-inizio/morte-rinascita. Con un percorso carsico nell’inconscio sociale, 17 anni dopo la profezia della fine del mondo, avviene il suicidio di massa Jonestown tramite l’unanime autodistruzione del perfetto cristallo di massa: “Il morire insieme come un tutt’uno sancisce l’apoteosi mortale del gruppo nel momento in cui sembra esserne la fine”. Pozzi afferma che “la fine del mondo” e “il finimondo” sono come due facce della stessa vicenda di fantasmi. Ciò che ha mosso Pozzi nelle sue ricerche per l’omicidio di massa è stato un illimitato piacere nell’immergersi nel tema della fine del mondo, cercando di addentrarsi nel modo in cui il sociale minaccia la sopravvivenza, leggendolo in chiave psicoanalitica. Pozzi si chiede se il desiderio della fine sia presente anche nel funzionamento sociale, oltre che in quello individuale. Studiando anche le iconografie della Salpêtrière, l'autore collega “la fine del mondo” e “il finimondo” alla sua ricerca ovvero ritiene che essi siano come dei giochi di parole intorno al tema dell’identità, come un tentativo di provare a cambiare e trasformare le vicende sociali che ruotano attorno al Sé. “La morte trasmuta il caotico fluire in qualcosa che è e si trasforma in un’identità conclusa”. Durante i suoi anni densi di ricerche e studi, arriva alla conclusione che tutte le culture si mettono in condizione di far finire il mondo e ritiene che chiunque si suicida, individuo o gruppo, non pensi al suicidio come morte in sé ma come possibilità di diventare un essere finito, di acquietare l’identità non appagata: in tal modo legge il suicidio di massa del gruppo indifferenziato del ’78 come un passaggio che permette l’identificazione da “gruppo magma-non conosciuto” a gruppo “Jonestown”, una comunità internazionale che perse la vita in gruppo, come “suicidio rivoluzionario” utilizzando il cianuro.
Tra gli interventi della sala si mette in luce il bisogno di speranza nel mondo per l’individuo e per la collettività a cospetto della distruttività che sembra oggigiorno tendere a predominare sulla scena; l’occorrenza di ricollocare l’umano al centro e la necessità della dimensione della morte perché permette, al contempo, di sperimentare il piacere nel sentirci vivi e avere degli obiettivi.
Vedi anche
Eventi scientifici: Psiche - Finimondo
