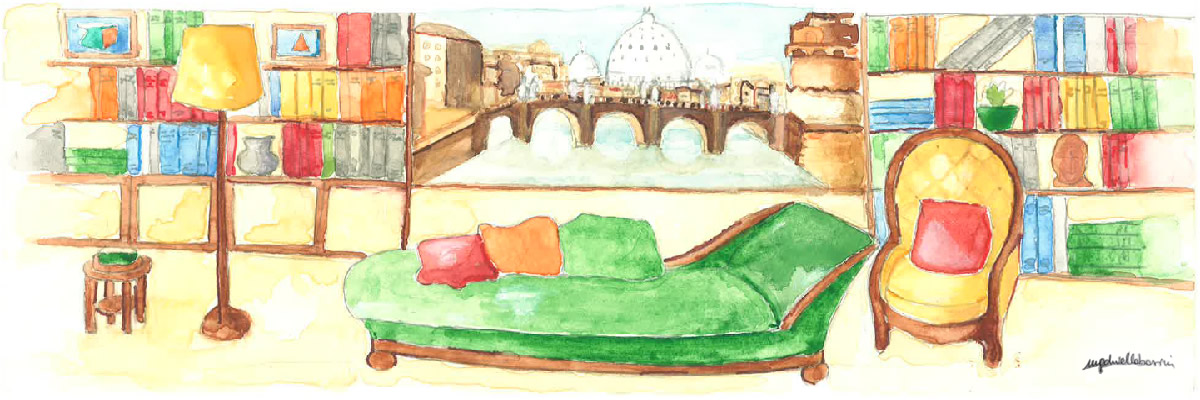Vergine A. - La ferita originaria - Commento (2013)
- Dettagli
- Categoria: Archivio Lavori Scientifici dal 2001 ad oggi
CENTRO DI PSICOANALISI ROMANO, CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA
BIBLIOTECA DEI CENTRI
9 marzo 2013
La ferita originaria - Commento di Adamo Vergine
(Volume a cura di Tonia Cancrini e Daniele Biondo. Scritti di Daniele Biondo, Francesco Burruni, Carla Busato Barbaglio, Tonia Cancrini, Mirella Galeota, Elisabetta Greco, Maria Adelaide Lupinacci e Marina Parisi).
Voglio dire subito che ho letto questo libro con interesse perché ci dà una rappresentazione viva del nostro lavoro, dove si colgono, pur nella diversità degli autori, momenti analoghi del funzionamento psichico degni di riflessione. Per me è stata una bella esperienza perché la modalità della presentazione dei casi mi ha permesso di entrare nel vissuto di quelle situazioni. L’importanza di questo libro è dato principalmente dai casi clinici di bambini, per lo più adottati, condotti e narrati sia da analisti analiticamente anziani che da analisti analiticamente giovani, che hanno avuto quel supplemento di formazione per poter essere valutati competenti a condurre analisi di bambini e adolescenti. Vengono descritte esperienze di presa in cura di bambini che all’origine della loro vita o comunque molto prematuramente avevano dovuto fare l’esperienza di un grave trauma o di molti, per cui si può dire che sono stati feriti all’origine della loro vita.
Come dice Tonia Cancrini nell’introduzione, questa pratica della psicoanalisi infantile sta diventando importante per tutti, anche per gli analisti di persone adulte – e questo è assolutamente vero almeno per me – perché aiuta a comprendere meglio qualsiasi tipo di sofferenza a tutte le età e soprattutto ad ampliare il grado di comprensione autoanalitica che ognuno di noi può avere di sé.
Dal momento che nessuno di noi è portatore di verità, ma soltanto di opinioni corroborate dalle propria esperienza, penso che la cosa più utile da fare nell’occasione della presentazione di un libro, non sia tanto quella di elogiarlo in una modalità formale o criticarlo per principio, ma quella di dialogarlo. Cioè di mettere a confronto i diversi punti di vista, perché soltanto in tal modo diventiamo insieme collaboratori del nostro sapere.
Il mio punto di vista, che mi immagino possa non essere condiviso da molti degli autori del libro, coglie in questo lavoro di analisi infantile di casi gravi una maggiore comprensione della relazione analitica dovuta ad alcuni fattori fondamentali: il maggiore investimento necessitato dalla gravità, la rottura del setting, a cui si è spesso costretti, il contatto corporeo e l’amplificazione emotiva dei vissuti. Dico maggiore comprensione non perché concepita teoricamente a livello razionale, ma perché si vede scaturire direttamente dall’inconscio come reazione al dolore provato e dal riuscire ad esistere insieme, ampliando la consapevolezza dei limiti ed inventando difese dal dolore per sé e per l’altro. Quindi potrebbe trattarsi di volta in volta sia di un’illusione, sia di una teoria-protesi, sia di una capacità di elaborazione, sia di un tentativo involontario di far capire che siamo tutti esseri umani sofferenti e fragili, ma anche capaci di una certa quantità di amore, non enorme e onnipotente come ognuno a livello cosciente potrebbe desiderare.
Per esempio mi ha colpito il fatto che pur avendo ognuno delle inclinazioni teoriche, si vede, per me abbastanza chiaramente, come quasi tutti rispondono al comportamento del paziente secondo la propria natura emotiva, a volte mettendo da parte la teoria, a volte nonostante l’attaccamento alla teoria.
Adelaide Lupinacci presenta un’osservazione madre-bambino alla Bick, dove sin dal primo giorno la madre confessa che non avrebbe voluto il bambino. Una volta questa madre sarebbe stata subito etichettata come cattiva, invece Adelaide ci fa vedere che oltre alla “madre sufficientemente buona” vi può essere una madre che sbaglia ma che è capace di riparare. Poiché quasi tutti citano le neuroscienze come un complemento teorico della psicoanalisi, almeno citando Mauro Mancia (il primo psicoanalista italiano di formazione kleiniana che si è occupato di neuroscienze, avendo una cattedra di neurofisiologia) - solo Carla Busato ed Elisabetta Greco si addentrano maggiormente in questo campo - allora quando Adelaide Lupinacci ci fa vedere la “riparazione” come lei la osserva, mi sono chiesto se scaturisce solo dal fatto che è un concetto inaugurato dalla Klein o anche perché è stato condiviso dalle neuroscienze.
Daniele Biondo prende dalle braccia della madre il paziente e così tenendolo lo porta nella stanza d’analisi. Un bambino brasiliano di otto anni adottato. L’analista non ha timore dei contatti corporei che a volte attivamente promuove come potrebbe fare una madre affettuosa, specialmente quando il paziente diventa violento. Il suo parlare non è particolarmente intrusivo anche se vorrebbe essere un’interpretazione e che diventi un dialogo si capisce dal fatto che il paziente risponde spesso con piacere e a tono, mentre quando la cosiddetta interpretazione diventa un intrusione violenta, il paziente la rifiuta e diventa ancora più cattivo. Così la relazione analitica sviluppa prevalentemente un’affettuosa esplicitazione dell’ascolto reciproco che rappresenta come le emozioni si muovono tra paziente e analista. Ho avuto l’impressione che per l’analista l’obbiettivo prioritario sia il paziente e non la teoria che se ne può dedurre o applicare. Sembra che lui punti a rendere evidente al paziente che esiste e che è in relazione con lui. Si vede che Biondo conosce le teorie, le regole e le tecniche, ma non si preoccupa di aderirvi religiosamente, così nell’operare tende a corrispondere alla sofferenza come un “compagno vivo”, quello di Alvarez che tutti gli autori hanno citato. “Vivo”, secondo me, significa lasciarsi trasformare dalla sofferenza del paziente, sia reagendo e adattandosi al vissuto del momento, sia modulandosi, creando o inventando, senza necessariamente ripetere metodi e teorie. In altri termini essere l’uno per l’altro. “Il bambino psicoanalista” lo chiama alla fine Daniele, come se si sentisse da lui curato.
Anche il caso di Francesco Burruni riguarda l’adozione di una bambina di dieci anni proveniente dall’Ucraina. Una situazione molto grave ed estrema. Per quel poco che l’autore è venuto a sapere della storia, nella mente della bambina ci sarebbe una madre naturale disperata perché la polizia le ha sottratto la figlia quando aveva cinque anni, da questo momento la bambina ha attraversato vari orfanatrofi, dove si presume che fosse trattata con estremo rigore dato il suo carattere ribelle, fino ad otto anni quando è stata adottata da una madre severa. Infatti Burruni ipotizza che tutte le misure che avrebbero dovute essere di protezione siano state invece dei traumi gravi, comprendendo anche l’adozione.
Sono situazioni in cui chi assume la presa in cura merita rispetto solo per la sofferenza che ha incontrato. La bambina non avendo più nulla da perdere, quando ha capito che l’analista non era la polizia né gli operatori degli orfanatrofi ha incominciato lei a torture lui, mettendo a soqquadro la stanza, affacciandosi alla finestra, gridando ai passanti, picchiando l’analista, saltando sui mobili ecc. Burruni provava a difendersi con le interpretazioni, ma lui stesso dice che erano inefficaci anzi sembravano alimentare la violenza. Lo scenario si trasforma dopo che l’analista discute la situazione con un gruppo di analisti, che gli consigliano di aumentare il numero delle sedute. Lo stesso autore riferisce che forse i colleghi hanno ipotizzato che la bambina non si sentisse veramente presa in carico. Alla “prima quarta seduta” l’analista propone di fare il gioco del fantasma che già avevano fatto altre volte. Lei si fa legare in vita con una corda e l’analista piano piano la solleva e la dondola, come se fosse un modo di cullarla - pensa l’analista - e senza sapere perché istintivamente gli viene da cantare una ninna nanna. A me, leggendolo, ha dato anche l’idea di un cordone ombelicale e ho pensato che questa era la prima volta che la relazione analitica, dopo un lungo periodo di accoglienza delle proiezioni poteva avere una svolta evolutiva, anche se la convinzione era quella di aver sempre provato a farlo con l’interpretazione. D’altra parte, penso che se l’analista non ne fosse stato convinto che quello era il modo migliore per stare con la paziente, la paziente non avrebbe potuto sentire che era stata accolta la proiezione di un oggetto interno. Dico questo perché anche io, come Burruini sono portato a fare un autoanalisi serrata e continua del lavoro analitico e come lui, se soffro molto, arrivo sempre a conclusioni che servono a non separarmi dall’originaria formazione teorica, così come la bambina non voleva una teoria diversa dalla sua. Quindi il fatto che l’analista sia riuscito poi a superare l’ostacolo della conservazione di sé, trasformando le proprie difese teoriche per avere cura profonda della bambina, mi sembra importante.
Il caso di Mirella Galeota riguarda un bambino di quattro anni che circa a 16 mesi era rotolato per una scala di 8 scalini, apparentemente incolume, ma soprattutto sembra che la coppia madre-bambino avesse molta difficoltà a comunicare. Viene inviato all’analisi a quattro anni per disturbo dello spettro autistico. Il bambino non parla, non guarda direttamente l’analista, “si aggira senza meta come un alieno o un robot” ed il primo sentimento dell’analista è quello di sentirsi esclusa. In tal caso è facile accogliere la proiezione del paziente che è fissato in uno schema in cui l’altro è il persecutore da evitare. Però, quando noi analisti mettiamo in scena un comportamento, se non ci crediamo e lo facciamo teoricamente non è sentito vero dal paziente. Infatti la Galeota è convinta che di fronte all’isolamento lei debba cercare attivamente il contato fisico o psichico con il paziente. Poi, sempre autenticamente, vedendo che il paziente veniva aiutato a mantenere il suo isolamento, pensa che forse questi suoi tentativi erano vissuti come intrusivi e violenti, analoghi a quelli della madre del paziente, ed allora nasce l’idea creativa. Prende un omino del meccano, se lo mette d’avanti ed incomincia a parlare a lui come se fosse il paziente. Un’idea geniale perché dopo un po’ il paziente comincia a rispondere come se desse voce all’omino. Il dado è tratto e l’analisi continua.
Elisabetta Greco prende in cura un bambino di otto anni con “disturbo schizofreniforme”, figlio non desiderato di genitori giovani, egoisti e violenti, poi separati. Penso che la diagnosi fatta sia stata suggerita da un sintomo a cui Searles attribuiva anche valore diagnostico e che riguarda l’identificazione con oggetti non umani, che però si muovono e compiono efficacemente un lavoro (lavatrice, aspirapolvere, ventilatore, frullatore etc.). Infatti Marco, così viene chiamato il paziente, imita in maniera perfetta il suono dell’aspirapolvere e anche di altri elettrodomestici Per un certo periodo il paziente in seduta suona e disegna elettrodomestici e a volte cerca il contato fisico, ma in una maniera singolare: strusciando la sua guancia sul viso dell’analista. La dottoressa onestamente dichiara che lei ha difficoltà a tollerare questi contatti fisici, ma anche la monotonia dei rumori di elettrodomestici, per motivi personali che conosce bene. Non dice nulla, ma probabilmente il paziente intuisce tale fastidio. L’analista non narra se tale comportamento del paziente fosse abituale anche con la madre, che viene descritta come rifiutante. Mi chiedo questo perché forse in tal caso il paziente cercava di trovarsi con un equivalente materno. Dopo un certo periodo il paziente, rassicurato di non essere inglobato dall’analista, inventa un’altro gioco: fa dei pallini di pongo, li mette sul tavolo e preme con un dito su ognuno come se fossero dei pulsanti. A questo punto l’analista, forse anche spinta dal senso di colpa del tacito rifiuto, risponde in maniera molto creativa. Prima nomina questi pallini con le parole che indicano emozioni diverse e poi, mettendo le sue mani a conca, gli dice mettili qui dentro. Secondo la mia opinione questo è il punto di svolta dell’analisi, dal quale prende avvio un intenso dialogo sui mostri che il paziente dice di avere nella mente e che l’analista dice di conoscere per averli attraversati e compresi. Così li elaborano insieme dialogando con i disegni, facendone uno ognuno e accompagnandolo con un commento verbale, prima solo da parte dell’analista poi, attraverso un’altra invenzione dell’analista, che incominciò a mettere nei disegni i fumetti con le parole, e Marco la imitò con piacere, fino ad acquisire un linguaggio coerente. Non ho capito quando tempo è durato questo percorso, sembra però che Marco a casa si comportasse come sempre e, nonostante tale furbizia, la madre forse aveva intuito i suoi progressi e lo portò ad un consultorio psichiatrico che fece la diagnosi di sindrome di Asperger e da quel momento non lo portò più in analisi.
Il caso di Marina Parisi è una bambina di 10 anni, Laura di origine latinoamericana, abbandonata appena nata e adottata, poi rifiutata, la successiva prima madrina morì. Quindi subì diverse adozioni provvisorie fino a quest’ultima che dovrebbe diventare definitiva , ma per la quale il tribunale dei minorenni ha chiesto una terapia psicoanalitica per il carattere violento e ribelle della bambina.
Anche questo è un caso molto grave che darà molto da patire all’analista.
Incomincia con il disprezzo e poi, sperimentando che l’analista contiene e tollera diventa sempre più violenta fino a mettere in subbuglio la stanza, a gettare a terra tutti i quadri rompendone i vetri ed anche a buttare dalla finestra la scatola dei giochi sui passanti. L’analista contiene molto, nel senso che tiene dentro, parla poco, non fa interpretazioni, tranne che qualche intervento generico sulla situazione che si sviluppa di volta in volta e devo dire sinceramente che personalmente condivido molto questo comportamento. L’analista a sua volta si fa contenere dal pensiero di Bion che articola coerentemente con le vicende delle sedute nella sua riflessione solitaria. Accoglie le proiezioni della paziente, ma si ribella anche quando dice che l’analista ha dei limiti e non può ingoiare sempre tutto. Condivido anche questo diritto che lei esplicita ad un certo punto quando di fronte ad un’ennesima violenza dice alla paziente: “ma per caso non rassomigli a quella strega del tuo sogno di molto tempo fa che voleva mangiare i bambini?”. La paziente accetta subito, come un’illuminazione, e dice: “hai ragione io non so amare”. Da quel momento lei stessa inizia a ricostruire il processo analitico e parallelamente la sua storia che scrive in un diario intitolato la storia del cuore. L’analista dice che nel tempo la paziente acquista una buona capacità di narrare e ne sembra contenta.
Carla Busato non presenta un lavoro clinico, ma pensieri e modi di vedere l’infanzia e la sua cura. Notazioni molto belle. Riporta riflessioni psicoanalitiche ma anche umane e di buon senso. Si addentra anche in molti risultati delle neuroscienze, mostrando un’adesione preferenziale al pensiero di Music, che concentra la sua attenzione sulla modalità involontaria di stare nella relazione al di là dei propositi coscienti. La Busato inizia con un interrogativo che le era stato posto da una paziente che non smetterà mai di farci riflettere. “Ma perché vuoi farmi vivere?”. Questo riguarda tutti gli analisti. Infatti, se fossimo veramente neutrali come dice la vecchia guardia analitica europea, coerentemente non dovremmo avere neanche questa aspettativa. Ma se abbiamo una vocazione alla cura non possiamo essere neutrali e d’altra parte si vede in tutti i casi clinici riportati onestamente come i vostri. Ma che cosa vuol dire questa nostra vocazione? Un grande amore per gli altri ed un io integrato come dice Tonia Cancrini? Oppure “stare nel piacere dell’incontro” come dice Carla Busato?
Sono d’accordo con “Il piacere dell’incontro” come segnale di un incontro inconscio già realizzato, ma non come una ricerca tecnica intenzionale. In quanto all’amore, in fin dei conti si può dire anche semplicemente così, ma vorrei aggiungere un’ipotesi di quale dinamica psichica ci porta a curare. Secondo me è una necessità inconscia che scaturisce sia dalla gratitudine per quegli aspetti della nostra psiche che sentiamo essere stati curati, sia da quelle macchie ancora cieche che ci sembra possano essere prese in considerazione attraverso il paziente che ce le rappresenta, ipotizzando ovviamente che noi non siamo mai completamente sani, senza conflitti e completamente integrati, almeno secondo le ipotesi nostre e dei neuro scienziati, che ritengono “il conflitto vicino all’ equilibrio” la base della vita e la patologia un’accentuazione della conflittualità. Questo però ci permette di investire molto, attraverso i pazienti che ce le rappresentano, le modalità psichiche che fanno soffrire e che a noi sono ancora oscure, per trasformarle in altre forse più economiche, ma mai totalmente risolutive.
Ognuno di voi ha fatto comprendere, chi più esplicitamente, chi implicitamente, che il paziente poteva rappresentare anche qualcosa di proprio. Questo aspetto lo condivido molto.
Per concludere, da voi ho imparato che, a prescindere dalle proprie inclinazioni teoriche, c’è un momento nella cura in cui la chiave terapeutica scaturisce direttamente dall’inconscio, se è stata preparata con l’accoglienza delle proiezioni, attraverso l’identificazione proiettiva di paziente e analista, e questo ci potrebbe spiegare perché, nonostante le diverse teorie, quasi tutti riescono a realizzare un certo grado di sollievo alla sofferenza.
In altri termini sembra che si possa enunciare un’ipotesi di questo tipo: è la sofferenza stessa che suggerisce e determina la modalità del prendersi cura, e non viceversa, cioè non è la competenza teorica e scientifica che decide come si può curare la sofferenza di cui stiamo facendo esperienza. Quindi come consiglia Bion conviene disporsi in un atteggiamento psichico che permetta di poter ridurre al minimo possibile il pregiudizio terapeutico cosciente. Quello che è diventato centrale nella nuova concezione di cura è “la relazione umana inconscia”, sempre meglio orientata in modo emotivamente competente, ma pur sempre “relazione umana”, cioè “non prescrivibile”, naturale, immediata e non prevedibile. In questo modo forse mi trovo ad imitare anche la bontà di Tonia che ringrazio insieme a tutti gli altri autori per avermi donato un’opportunità a riflettere sul nostro lavoro.